L’IA offre informazioni. Dio offre saggezza.
di Vineet Rajan
Il modello dati–informazione–conoscenza–saggezza pone l’intelligenza artificiale al suo posto.
Articolo tradotto e pubblicato con il permesso di Christianity Today.
Da ufficiale di intelligence dei Marine nella mia vita precedente, il mio compito era aiutare i leader di alto livello a rispondere alla difficile domanda: «Cosa dovrei fare?». Dovevo raccogliere milioni di dati, organizzarli in informazioni, contestualizzarli e, attraverso l’analisi, dare loro significato in modo da conseguire la conoscenza della situazione. Gli ufficiali superiori prendevano tale conoscenza e, usando la saggezza nata dall’esperienza, decidevano come agire. Queste decisioni potevano significare la vita o la morte per gli uomini e le donne sotto il loro comando e, in quanto ufficiali, sentivamo regolarmente il peso di quella responsabilità.
Oggi, da padre, marito e amministratore delegato, molte delle decisioni che prendo hanno ancora grande peso. Come esseri umani attraversiamo sempre fasi della vita che comportano dei rischi: la crescita dei nostri figli, lo stato di salute del nostro matrimonio, il posto di lavoro dei nostri collaboratori. Tutti prendiamo decisioni ogni giorno e ci auguriamo che siano prese con saggezza. Nell’era dell’intelligenza artificiale ha senso inserire questo potente strumento nei nostri processi decisionali in maniera appropriata.
Il processo che seguivo da ufficiale di intelligence, passare dai dati che fossero usate per decisioni sagge. non è molto diverso da come molti di noi prendono decisioni nella vita quotidiana. In effetti il modello DICS (Dati, Informazione, Conoscenza, Saggezza) stabilito più di trent’anni fa dal sistemista Russell Ackoff, coglie passaggi che molti di noi compiono inconsciamente nel passare dai dati di base alla saggezza. In questo quadro, i dati diventano informazione quando sono organizzati e inseriti in un contesto; diventano conoscenza quando l’informazione viene analizzata e assume significato; e diventa saggezza quando comprendiamo come applicarla.
Se facciamo un’analisi onesta, stiamo annegando nei dati e siamo inondati di informazioni, eppure cerchiamo sempre conoscenza e saggezza. Per fortuna, gli strumenti di AI possono aiutare in buona parte di questo processo. Le loro capacità algoritmiche e computazionali sono perfettamente adatte a raccogliere terabyte di dati e a organizzarli e contestualizzarli in informazioni utili per il processo decisionale, solitamente in pochi secondi piuttosto che nelle ore o nei giorni che ci vorrebbero a un essere umano.
L’intelligenza artificiale ci fornisce conoscenza informativa, ma è anche schiava dei dati e delle informazioni a sua disposizione. Per le decisioni complesse della vita, quelle che comportano un vero rischio, spesso relazionale, abbiamo bisogno di qualcosa di più dell’informazione.
La conoscenza può essere informativa, esperienziale o idealmente entrambe. La definizione biblica di conoscenza va oltre il mero dato organizzato e l’informazione contestualizzata. Al contrario, la visione cristiana della conoscenza è profondamente radicata in persone concrete che vivono esperienze in relazione con altri, sia con Dio sia con altri esseri umani (Giovanni 13:35; 2 Corinzi 4:5-7).
Le Scritture parlano di come Dio vuole che lo conosciamo—certamente attraverso la conoscenza informativa, ma in ultima analisi in una relazione personale. Mosè conobbe Dio. Davide conobbe Dio. In modo simile ma diverso, Adamo conobbe Eva. La conoscenza che Dio desidera per noi è intima ed esperienziale, non solo informativa.
L’AI può aiutarci in molti aspetti della vita, ma, come ogni cosa creata, ha anche i suoi limiti. Invece di usare strumenti di AI per generare dati e informazioni, molti cercano di sfruttare tali sistemi per produrre conoscenza esperienziale e persino saggezza.
Un recente saggio pubblicato sulla Harvard Business Review ha evidenziato che il principale impiego dell’AI è la «terapia/compagnia». Riconoscendo le differenze tra terapia e compagnia, l’autore Marc Zao-Sanders li ha raggruppati in un’unica categoria perché entrambi «soddisfano un bisogno umano fondamentale di connessione emotiva e supporto». Il legame umano e il fatto di essere conosciuti dagli altri sono parte essenziale dell’essere umani. Pur descrivendo i vantaggi di usare l’AI in questo modo, l’articolo motiva i suoi argomenti con ragioni di efficienza: è disponibile 24 ore su 24, costa poco o nulla e non «giudica».
Ma l’AI non è efficace sul piano relazionale. Non può offrire compagnia per gli stessi motivi per cui è limitata nel fornire conoscenza esperienziale o saggezza: non è una persona incarnata, dotata di prospettive ed esperienze da cui trarre empatia e affiancarci nella vita. Ed è qui la sfida. L’AI non può sapere cosa significhi essere umani perchéi è non umana. E nel mezzo della cultura occidentale in cui vi è una propria epidemia di solitudine, imitare le relazioni con l’IA ha già avuto tragiche conseguenze.
Tentare di applicare l’IA in questo modo equivale a tornare nella caverna di Platone alla ricerca delle ombre di una relazione auto-gratificante, invece di godere dell’essenza delle relazioni. Così facendo, privilegiamo l’efficienza all’efficacia, l’artificiale al reale.
Sebbene l’IA sia molto ben addestrata per i problemi complicati, gli esseri umani sono complessi; ci servono la conoscenza esperienziale e la saggezza data da Dio. Potremmo cercare di usare l’IA oltre i suoi limiti di elaborare problemi complicati e fornire conoscenza informativa, spingendoci nei territori della conoscenza esperienziale e della compagnia, ma sarebbe imprudente farlo.
Vineet Rajan
Vineet Rajan è CEO di Forte, la piattaforma di mental fitness a crescita più rapida. Ha conseguito lauree magistrali a Stanford e Cambridge, è un veterano dei Marines ed è consulente per AI and Faith.

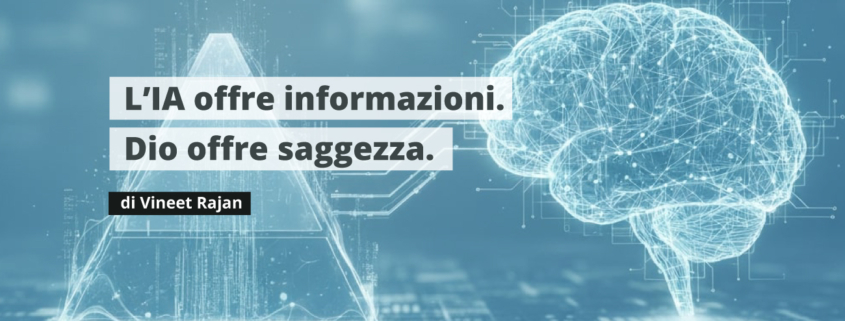


Trackbacks & Pingbacks
[…] L’IA offre informazioni. Dio offre saggezza. proviene da DiRS […]
I commenti sono chiusi.