di Andrew Shepherd
(tr. di Claudio Monopoli | Foto di Gabriele Magnano)
Oggi è impossibile evitare le notizie che ogni giorno descrivono in dettaglio gli impatti negativi che l’attività umana ha sul pianeta. Dalle montagne più alte alle profondità dell’oceano, nessun luogo della terra appare incontaminato[1]. Nel corso della nostra breve storia come specie abbiamo modificato e trasformato l’ambiente che ci circonda – dalla caccia, che ha portato all’estinzione varie specie animali, all’emergere dell’agricoltura circa 12–15.000 anni fa, fino ad arrivare negli ultimi cinquant’anni allo sviluppo di megalopoli. Ma ora, che sia invisibile all’occhio nudo – come i livelli in rapido aumento delle emissioni di gas serra nell’atmosfera – o chiaramente visibile – come l’onnipresente plastica nei nostri corsi d’acqua, oceani e lungo le coste – è evidente che la nostra relazione con il resto del creato sia terribilmente distorta. La nostra azione di distruzione degli habitat e di inquinamento del suolo, dei corsi d’acqua, degli oceani e dell’atmosfera sta contribuendo direttamente a un drammatico tramonto di altre specie[2]. L’Homo sapiens sta distruggendo il tessuto stesso della vita: siamo la causa primaria della sesta grande estinzione di massa attualmente in corso[3].
Cosa pensa il Dio che professiamo di adorare riguardo a questo cataclisma ecologico? Quale dovrebbe essere la nostra risposta come seguaci di Gesù a questa enorme perdita di biodiversità?
Di fronte a questa minaccia esistenziale, gran parte della teologia è spesso completamente antropocentrica. Abbiamo sviluppato teologie “ultraterrene” in cui le altre specie e l’ordine creato sono visti semplicemente come sfondo per quello che è concepito come l’evento chiave: la relazione di Dio con l’Homo sapiens. Ma la nostra specie è davvero ancora il centro della storia della relazione di Dio con tutta la creazione? Scavando più a fondo nella Scrittura e nella tradizione cristiana e impegnandoci con le scoperte della scienza contemporanea ci rendiamo conto che potremmo aver arrogantemente sopravvalutato noi stessi e sottovalutato il significato delle altre creature.
Creature come noi
Che Dio abbia un profondo amore per tutto il creato è evidente dal racconto iniziale della creazione che contiene l’affermazione, ripetuta sette volte dal Creatore, della “bontà” della creazione stessa (Gen 1:2–23a). Poco oltre, nel racconto del diluvio universale (Gen 6––9), Noè ubbidisce al Signore e costruisce un’arca per garantire la conservazione della biodiversità di fronte al conseguente “assorbimento della vita” (7:23). Mentre l’amore del Creatore per tutto ciò che è stato creato è chiaro, fino a che punto le creature di Dio rispondono a questo amore? Qual è la natura della relazione che la miriade di creature ha con il suo Creatore?
Attraverso i recenti progressi della scienza ora sappiamo che condividiamo tra il 96 e il 99% dello stesso DNA dei nostri parenti più stretti, scimpanzé, bonobo e gorilla. Oltre a questa somiglianza genetica, la ricerca dei comportamentisti animali sta abbattendo il muro concettuale che abbiamo eretto tra noi stessi e le altre creature. Di quest’ultime, lungi dall’essere macchine che agiscono solamente per istinto, automata, incapaci di provare dolore, come tristemente affermato da René Descartes, stiamo progressivamente scoprendo la profondità della vita interiore. Le prove che queste provino una serie di emozioni – dolore, gioia, sofferenza, appagamento, rabbia, depressione e solitudine – continuano a crescere. Molte delle azioni che attribuiamo in modo univoco agli umani – pianificazione e cooperazione, inganno, altruismo, lutto, perdono, rancore, pace, umorismo – sono evidenti anche in altre specie[4].
Le creature portate alla vita dal soffio vitale di Dio
Anche la Scrittura dipinge le altre creature non come automi né come figure piatte simili a cartoni, ma piuttosto come esseri dotati di dinamicità, con un’identità, un organismo e con capacità di relazione con il loro Creatore. L’immagine così evocativa, usata in Genesi 2:7, del Signore Dio che respira la vita nelle narici di ̓ādām, la creatura terrestre, viene ripetuta più volte in tutto l’Antico Testamento[5]. Il salmista, osservando tutte le creature plasmate tramite la saggezza di Dio, attinge alle immagini del respiro/Spirito[6] di Dio che si libra sulle acque del creato (Gen 1:2), e scrive:
Tu nascondi la tua faccia, e sono smarriti;
tu ritiri il loro fiato e muoiono,
ritornano nella loro polvere.
Tu mandi il tuo Spirito e sono creati,
e tu rinnovi la faccia della terra (Salmo 104:29–30)
Le Scritture testimoniano che la vita di tutte le creature dipende da questo respiro vitale (ruach) di Dio. Qoelet, l’autore di Ecclesiaste, comprese che la vita e il destino dell’uomo sono indissolubilmente legati alla vita di altre creature. Di fronte alla fragilità e alla natura transitoria della vita umana, ha sottolineato che non dovremmo considerarci di tanto superiori, ma dovremmo ricordarci che anche noi siamo animali.
Io ho detto in cuor mio: «Così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li metta alla prova, ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie». 19 Infatti, la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie; agli uni e alle altre tocca la stessa sorte; come muore l’uno, così muore l’altra; hanno tutti un medesimo soffio, e l’uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia; poiché tutto è vanità. 20 Tutti vanno in un medesimo luogo; tutti vengono dalla polvere, e tutti ritornano alla polvere. 21 Chi sa se il soffio dell’uomo sale in alto, e se il soffio della bestia scende in basso nella terra? (Eccl 3:18–21).
Le creature come agenti di Dio
Non solo condividiamo con le creature lo stesso respiro/Spirito che anima la vita, ma la Scrittura mostra come anche gli animali siano agenti della grazia di Dio e messaggeri del giudizio di Dio. In 1 Re 17:1–7 il profeta Elia annuncia al re idolatra Achab l’inizio di una siccità. Fedele nel pronunciare il giudizio di Dio, lo stesso Elia deve comunque affrontare personalmente le conseguenze di questa siccità. Sorprendentemente, sono i corvi, animali impuri per la legge, che diventano agenti della grazia di Dio, fornendo a Elia un pasto mattutino e serale. Allo stesso identico modo, un altro dei profeti di Dio diventa il destinatario delle azioni salvifiche di una creatura animale. Israele, un popolo di terra nutriva una profonda antipatia per i mari. Ciononostante, Giona, piuttosto che dirigersi a Ninive, la capitale dell’impero assiro, per annunciare la parola di Dio, che percepisce come una certa condanna a morte, sceglie il terrore del mare. Gettato in mare, è una creatura delle temute acque profonde che inghiotte Giona, salvandolo così dall’annegamento. Contrariamente a Giona, il grande pesce è poi obbediente a Dio, e restituisce Giona alla sua vita terrestre per ricevere di nuovo le istruzioni del Signore.
In un altro episodio comico è un fedele asino che salva il suo proprietario – l’indovino Balaam – dall’angelo dell’Eterno che brandisce una spada. Convocato da Balak per maledire gli Israeliti, Balaam batte il suo asino, ignaro che l’improvviso cambio di direzione dell’animale lo stia salvando dal pericolo invisibile del giudizio dell’Eterno. Donatagli la parola, l’asino supplica la sua innocenza. La sua testimonianza è confermata dall’angelo dell’Eterno che annuncia che se non fosse stato per l’intervento del suo asino, Balaam sarebbe stato abbattuto. Smontato dall’asino e dalla sua posizione elevata, Balaam è costretto a stare accanto alla sua creatura e, fermo e silenzioso, è tenuto ad ascoltare di nuovo le istruzioni che finora non ha completamente rispettato (Nm 22:1–35). Vale la pena riflettere a quanto spesso noi, come Giona e Balaam, trascuriamo o ignoriamo le modalità in cui le creature che ci circondano diventano messaggeri di grazia e agenti di liberazione. Superare una visione del mondo antropocentrica richiede che, come Balaam, non sediamo, metaforicamente, dall’alto del nostro cavallo (asino).
Le creature richiedono la nostra attenzione
Nella tradizione cristiana è diventato comune parlare dei due libri della rivelazione di Dio, ovvero quello della creazione e quello della Scrittura. Tuttavia, ascoltare ciò che il libro della creazione ci sta dicendo, in particolare attraverso le espressioni dei nostri simili, richiede una nuova postura, quieta, caratterizzata da umiltà e attenzione per imparare e correggere ciò che è sbagliato. Giobbe, avendo sperimentato tremende avversità, si ritrova circondato da amici, che seppur con buone intenzioni, spiegano che la causa del suo dolore è la colpa inconfessata. Giobbe difende la sua innocenza, invitando le altre creature a difendere la sua giustizia, e invita i suoi amici consiglieri ad imparare anche da queste (Gb 12:7–10). Più tardi, Giobbe stesso è costretto a seguire il suo consiglio. Sopraggiunge una voce proveniente da un turbine: l’Eterno, interroga Giobbe, offrendo una descrizione dettagliata della complessità e del mistero della creazione (Gb 38––41). Di fronte alla travolgente meraviglia di un ecosistema pieno di vita dinamica di cui egli stesso è parte, e dal quale non può prescindere, Giobbe confessa umilmente: “Il mio orecchio aveva sentito parlare di te ma ora l’occhio mio ti ha visto.” (Gb 42:5). Non è un caso che in seguito, un altro individuo ubbidiente e giusto, Gesù, impartirà le stesse istruzioni ai suoi discepoli, chiamandoli a “considerare” (osservare, prestare attenzione a) il comportamento virtuoso dei corvi[7].
Tuttavia, oltre a incontrare Dio anche attraverso la contemplazione della creazione, cosa potrebbe significare porre attenzione ulteriormente al mondo delle altre creature e comunicare direttamente con loro? Spesso capita quotidianamente di parlare con altre creature – si pensi alle interazioni con gli animali domestici – ma fino a che punto ascoltiamo sinceramente le loro voci? La nostra incapacità di farlo sembra legata (1) all’assunto cartesiano secondo cui solo gli umani possiedono il linguaggio e, (2) a un malinteso su quale sia lo scopo principale del linguaggio. Ormai sembra che le prove stiano confutando il concetto che solo gli umani comunichino attraverso la lingua, tuttavia tendiamo comunque ancora a concepire il linguaggio in modo autoreferenziale: la lingua, crediamo che ci dia la capacità di rappresentare e interpretare il mondo che ci circonda. Se da una parte questo è vero, non è tuttavia lo scopo principale del linguaggio. Finora ho tracciato i seguenti temi: a) il respiro/Spirito che anima noi e la matrice della vita sulla Terra, e b) il linguaggio che piuttosto che distinguerci da altre creature è un’attività reciproca che collega noi agli umani, ad altre specie e a Dio. Queste tematiche sono intrecciate in un passaggio poetico del filosofo ambientalista David Abram:
Il linguaggio orale si diffonde dentro di noi – le nostre frasi risuonano per la stessa aria che nutre i cedri e gonfia i cumuli. Distesi e immobilizzati sulla superficie piana, le nostre parole tendono a dimenticare che sono sostenute da questa terra spazzata dal vento; iniziano a immaginare che il loro compito principale sia quello di fornire una rappresentazione del mondo (come se fossero al di fuori di questo mondo e non facessero davvero parte di esso). Tuttavia, il potere del linguaggio rimane, in primo luogo, un modo di cantare se stessi a contatto con gli altri e con il cosmo – un modo per colmare il silenzio tra se stessi e un’altra persona, o un orso nero sorpreso, o la luna crescente che si alza come una vela fluttuante sopra il tetto. Che sia suonato sulla lingua, stampato sulla pagina o luccicante sullo schermo, il dono principale della lingua non è di riproporre il mondo che ci circonda, ma di chiamarci alla presenza vitale di quel mondo – e alla presenza profonda e attenta l’un con l’altro[8].
Condividiamo, con le altre creature, diverse quantità dello stesso codice genetico, lo stesso respiro che anima la vita e, con molti, la capacità di linguaggio. E se da un lato la lingua ci convoca in una “presenza profonda e attenta l’un con l’altro“, essa ha una funzione ancora maggiore. Teologicamente, lo scopo principale del dono del linguaggio è quello di assistere le creature nella lode del loro Creatore. E, se da una parte possiamo pensare che solo l’umanità si impegna nell’adorazione, la Scrittura sostiene che non è così. Il Salmo 148 ritrae tutta la creazione – esseri angelici, sole, luna, stelle, creature marine e oceani, sistemi meteorologici, paesaggi e alberi di habitat terrestri e tutte le specie selvatiche e domestiche che risiedono in essi – insieme all’umanità, come un’enorme coro che offre la sua lode al Signore. In effetti, il libro dei Salmi si conclude con l’esortazione che tutte le creature offrano il respiro che è stato loro donato per la lode al loro Creatore: “Ogni creatura che respira, lodi il SIGNORE” (Sal 150:6).
Le creature come compagni di adorazione
Perciò, il fattore più importante di tutti, la Scrittura, ci ri–direziona e ri–orienta nel concetto che oltre ad essere messaggeri di grazia e giudizio e insegnanti di virtù, le altre creature possono essere compagni di adorazione. Questa immagine di tutte le creature di Dio che adorano il loro Creatore e Redentore raggiunge il suo apice nella visione apocalittica di Giovanni. Quattro creature viventi – simboli di creature selvagge (un leone), animali domestici (un bue), esseri umani e vita aviaria (un’aquila) – si radunano davanti al trono di Dio dichiarando che la vita di tutte le creature deriva dall’iniziativa di Dio (Ap 4:11). La loro ragione di esistere è di dare gloria a Dio. E, mentre l’Agnello di Dio, in piedi accanto al trono, apre la pergamena che dichiara il giusto giudizio, rivendicando il regno dell’amore di Dio, queste quattro creature sono raggiunte da “tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare”, da ogni creatura estinta o esistente, nell’offrire lode eterna:
«A colui che siede sul trono, e all’Agnello, siano la lode, l’onore, la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 5:13)
Di fronte alla diminuzione della biodiversità ci viene imposto per via di questo amore a proteggere la vita dei nostri compagni coristi affinché le loro voci possano continuare a lodare il loro Creatore.
Domande per la discussione
- Leggi il libro di Giona. Quale ruolo gli animali hanno nel piano di Dio in questo libro?
- Leggi il Salmo 148 o Apocalisse 4-5, quale ruolo hanno gli animali in questi passi?
- Quali esperienze hai avuto nelle quali altre creature sono state messaggeri della grazia di dio o agenti di liberazione/libertà.
- Che differenza farebbe concepire le altre creature come agenti di Dio e come compagni di adorazione per la tua vita? Che differenza farebbe per la tua università? Il tuo movimento studentesco? La tua scuola?
Letture ulteriori
- Bauckham, Richard. Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation. Waco, TX: Baylor University Press, 2010, tr. it.
- Clough, David L. On Animals: Theological Ethics. 2. London: Bloomsbury, 2019.
- Clough, David L. On Animals: Systematic Theology. Vol. 1. London: T. & T. Clark, 2012.
- Deane-Drummond, Celia, and David L. Clough. Creaturely Theology: On God, Humans and Other Animals. London: SCM Press, 2009.
- Harris, Peter. Kingfisher’s Fire: A Story of Hope for God’s Earth. Oxford: Monarch, 2008.
- Kolbert, Elizabeth. The Sixth Extinction: An Unnatural History. New York: Henry Holt and Co., 2014.
[1] A.J. Jamieson et al. “Microplastics and synthetic particles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest marine ecosystems on Earth” R. Soc. open sci. 6:180667, https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.180667; Heather Saul, “Human waste left by climbers on Mount Everest is causing pollution and could spread diseases” Independent, 3 March 2015, https://www.independent.co.uk/environment/human-waste- left-by-climbers-on-mount-everest-is-causing-pollution-and-could-spread-diseases-10081562.html.
[2] WWF. 2018. Living Planet Report – 2018: Aiming Higher. Grooten, M. and Almond, R.E.A. (Eds). WWF, Gland,Switzerland, https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1187/files/original/LPR2018_F ull_Report_Spreads.pdf?1540487589.
[3] Mentre la popolazione umana di 7,6 miliardi rappresenta solo lo 0,01% di tutte le forme di vita, dal sopraggiungimento dell’Homo sapiens la nostra azione ha portato all’estinzione dell’83% di tutti i mammiferi non addomesticati; l’80% dei mammiferi marini; il 50% delle piante; e il 15% dei pesci. Guarda: Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo (2018), “The Biomass Distribution on Earth” Proceedings of the National Academic of
Sciences 115 (25): 6506-11. Se da un lato l’estinzione è un normale processo evolutivo gli scienziati stimano che il tasso di estinzione delle specie è più alto di 100-10.000 volte rispetto al tasso di estinzione di fondo.
[4][4] Guardare allo studio del primatologo ed etologo tedesco, Frans de Waal, particularly: Our Inner Ape (New York: Riverhead Books, 2005) and Mama’s Last Hug: Animal Emotions and What They Tell Us About Ourselves (New York: W.W. Norton, 2019).
[5] Genesi 6:17; Genesi 7:21-22; Giobbe 12:10, 27:3 32:8,33:4, 34:14-15; Salmi 104:29-30, Isaia 42:5, 57:16
[6] La parola ebraica ruach può essere tradotta come vento, soffio/fiato, o Spirito.
[7] Luca 12:24; guarda Andrew Shepherd, “Being ‘Rich towards God’ in the Capitalocene: An Ecological/Economic Reading of Luke 12.13-34” The Bible Translator (forth.).
[8] Becoming Animal: An Earthly Cosmology (New York: Pantheon Books, 2010), 11, corsivo dell’autore
Andrew Shepherd ha fatto parte del movimento IFES in Nuova Zelanda, Christian Telliary Students (TSCF), dal 1995 al 1999. Negli ultimi due decenni ha lavorato nei settori dell’educazione teologica, ambientale e internazionale e della pratica della conservazione. A Rocha Aotearoa in Nuova Zelanda, fino a poco tempo fa come co–direttore. Ha ricoperto il ruolo di insegnante e ricercatore presso numerosi istituti di istruzione accademica ed è attualmente docente di teologia ed etica all’Università di Otago, in Nuova Zelanda.




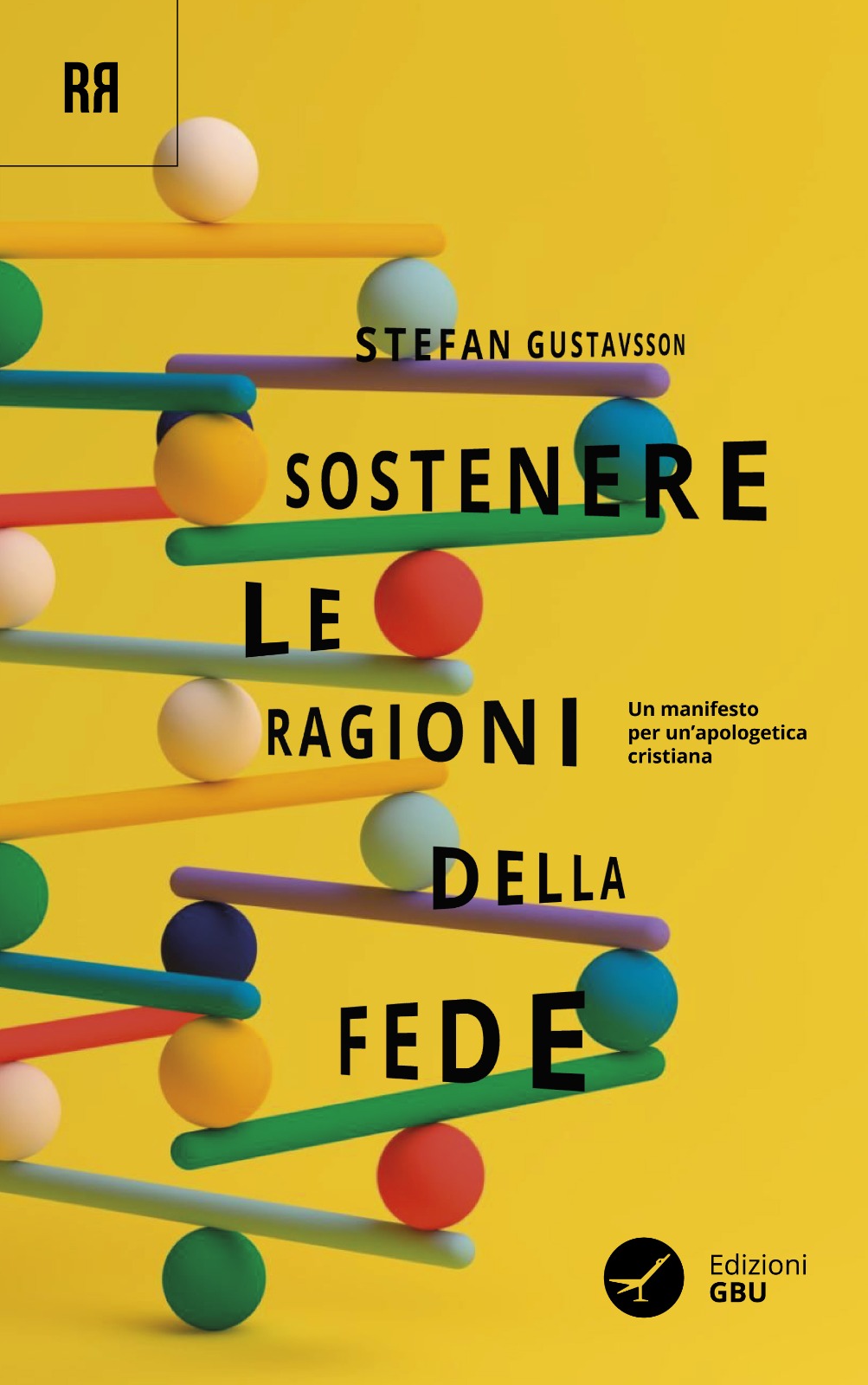 Oggi sono i fondamenti della fede a essere sotto attacco, non il modo in cui formuliamo la nostra visione del battesimo o cosa pensiamo del millennio. Dio esiste davvero o è tutta immaginazione e suggestione, una forma di autoinganno religioso? Se Dio esiste, come possiamo sapere chi egli è? Come possiamo metterci in contatto con lui? Possono avvenire miracoli in un mondo in cui possiamo descrivere tutto utilizzando le leggi della natura? I testi biblici sono attendibili? Sono parole venute da Dio? Gesù è esistito e, se è esisto, chi era? Cosa è successo dopo la sua morte e sepoltura? È vivo oggi – e dove si trova? Perché una persona non si può relazionare direttamente con Dio senza la “mediazione” di Gesù? Come possono le nostre mancanze, i nostri errori e i passi falsi – il nostro “peccato” – essere qualcosa di così grave da separarci da Dio? E come può la morte di Gesù sulla croce cambiare la situazione? È ragionevole considerare le altre religioni come vicoli ciechi? L’uomo è influenzato dall’ereditarietà e dall’ambiente, dalla biologia e dalla sociologia, è davvero libero e responsabile? E non è umiliante sottomettersi a Dio rinunciando al proprio diritto all’autodeterminazione? In poche parole, si tratta dello scontro frontale tra la fede cristiana e la visione laica della vita, indipendentemente dal fatto che essa arrivi a noi sotto forma di culto della ragione dell’umanesimo illuminista o del relativismo postmoderno.
Oggi sono i fondamenti della fede a essere sotto attacco, non il modo in cui formuliamo la nostra visione del battesimo o cosa pensiamo del millennio. Dio esiste davvero o è tutta immaginazione e suggestione, una forma di autoinganno religioso? Se Dio esiste, come possiamo sapere chi egli è? Come possiamo metterci in contatto con lui? Possono avvenire miracoli in un mondo in cui possiamo descrivere tutto utilizzando le leggi della natura? I testi biblici sono attendibili? Sono parole venute da Dio? Gesù è esistito e, se è esisto, chi era? Cosa è successo dopo la sua morte e sepoltura? È vivo oggi – e dove si trova? Perché una persona non si può relazionare direttamente con Dio senza la “mediazione” di Gesù? Come possono le nostre mancanze, i nostri errori e i passi falsi – il nostro “peccato” – essere qualcosa di così grave da separarci da Dio? E come può la morte di Gesù sulla croce cambiare la situazione? È ragionevole considerare le altre religioni come vicoli ciechi? L’uomo è influenzato dall’ereditarietà e dall’ambiente, dalla biologia e dalla sociologia, è davvero libero e responsabile? E non è umiliante sottomettersi a Dio rinunciando al proprio diritto all’autodeterminazione? In poche parole, si tratta dello scontro frontale tra la fede cristiana e la visione laica della vita, indipendentemente dal fatto che essa arrivi a noi sotto forma di culto della ragione dell’umanesimo illuminista o del relativismo postmoderno. Stefan Gustavsson,
Stefan Gustavsson, 
 Il tema del convegno era “curare la fede”, ovvero afferrare, proteggere e proclamare la verità. Ci sono stati diversi aspetti che mi hanno colpito, che mi hanno fatto riflettere su come io vivo la mia fede nel contesto storico e sociale in cui mi trovo, al di fuori della chiesa ma anche al suo interno. Pablo Martinez, infatti, ha portato inizialmente l’attenzione sull’epoca in cui ci troviamo, caratterizzata da un soggettivismo di fondo in cui ognuno si è artefice della propria etica, dove è difficile presentare la nostra fede come LA verità e non UNA verità tra le tante. Il risvolto morale è profondamente implicato, proprio perché ciò che viviamo nella pratica, ciò che rappresenta l’esperienza di vita che necessariamente deve rinnovarsi costantemente, è il frutto della verità che facciamo nostra. È così allora, che anche all’interno della chiesa, la Bibbia diventa solo uno strumento che orienta e indirizza e che viene relativizzata dal mondo e dai cristiani stessi. Per opporci alla distruzione della fede, quindi, è importante sapere in cosa crediamo e cosa proteggiamo: una verità RIVELATA da cui possiamo attingere meditando la Parola; una verità INCARNATA nella persona di Gesù Cristo, immagine dell’amore e della Grazia che deve formarsi progressivamente in noi e una verità ILLUMINATA tramite l’azione dello spirito santo che ci guida e ci sostiene. Come ultimo oggetto di riflessione, il dr. Martinez ha portato la storia degli amici di Daniele nella fornace come esempio pratico di una fede che sa dire no. La loro, infatti, è stata la dimostrazione di cosa significhi avere una fede integra e quindi matura, che sa discernere, che sa mettere dei limiti alla tolleranza; una fede equilibrata, radicale ma non estremista, una fede ben fondata sulla fiducia di Dio, sull’ubbidienza e sul coraggio.
Il tema del convegno era “curare la fede”, ovvero afferrare, proteggere e proclamare la verità. Ci sono stati diversi aspetti che mi hanno colpito, che mi hanno fatto riflettere su come io vivo la mia fede nel contesto storico e sociale in cui mi trovo, al di fuori della chiesa ma anche al suo interno. Pablo Martinez, infatti, ha portato inizialmente l’attenzione sull’epoca in cui ci troviamo, caratterizzata da un soggettivismo di fondo in cui ognuno si è artefice della propria etica, dove è difficile presentare la nostra fede come LA verità e non UNA verità tra le tante. Il risvolto morale è profondamente implicato, proprio perché ciò che viviamo nella pratica, ciò che rappresenta l’esperienza di vita che necessariamente deve rinnovarsi costantemente, è il frutto della verità che facciamo nostra. È così allora, che anche all’interno della chiesa, la Bibbia diventa solo uno strumento che orienta e indirizza e che viene relativizzata dal mondo e dai cristiani stessi. Per opporci alla distruzione della fede, quindi, è importante sapere in cosa crediamo e cosa proteggiamo: una verità RIVELATA da cui possiamo attingere meditando la Parola; una verità INCARNATA nella persona di Gesù Cristo, immagine dell’amore e della Grazia che deve formarsi progressivamente in noi e una verità ILLUMINATA tramite l’azione dello spirito santo che ci guida e ci sostiene. Come ultimo oggetto di riflessione, il dr. Martinez ha portato la storia degli amici di Daniele nella fornace come esempio pratico di una fede che sa dire no. La loro, infatti, è stata la dimostrazione di cosa significhi avere una fede integra e quindi matura, che sa discernere, che sa mettere dei limiti alla tolleranza; una fede equilibrata, radicale ma non estremista, una fede ben fondata sulla fiducia di Dio, sull’ubbidienza e sul coraggio.

 Darrell L. Bock
Darrell L. Bock


























































 Ed Shaw
Ed Shaw