Pedagogia, razionalismo e religiosità
Lunedì 9 Aprile 2018
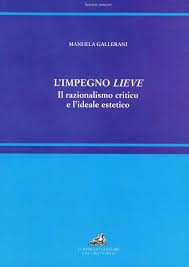 MANUELA GALLERANI, L’impegno lieve. Il razionalismo critico e l’ideale estetico, Loffredo Editore, Napoli 2012
MANUELA GALLERANI, L’impegno lieve. Il razionalismo critico e l’ideale estetico, Loffredo Editore, Napoli 2012
pagine 170.
Le ragioni di questa breve e spero scorrevole recensione sono prima di tutto personali, nella misura in cui ogni credente tiene alla correttezza critica. In un volume che vuole essere – ed in parte riesce nel suo intento – un riassunto programmatico del razionalismo critico erede dell’insegnamento di G. M. BERTIN nel campo della pedagogia, colpisce – pur nel continuo e corposo richiamo all’etica – la totale e completa mancanza di qualsivoglia citazione di autori anche solo lontanamente legati allo sviluppo del pensiero cristiano. In effetti l’autrice non si pone scrupoli ad accostare da pagina 93 a pagina 106 in un paragrafo dal titolo “L’abitare etico e il lettore (etico)” autori come ARISTOTELE, HEIDEGGER, NIETZSCHE attraverso la rilettura di G.M. BERTIN (Nietzche. L’inattuale, idea pedagogica, La Nuova Italia, Firenze 1977) . Sono queste tutte citazioni utili, ma parziali perché saltano a piedi pari circa 2300 anni di sviluppo del pensiero occidentale, per portare l’autrice alla definizione di “abitare etico” fatta in nota a pagina 100,
che ritengo utile citare: “Con la locuzione abitare etico … … si intende un abitare orientato secondo posture di vita autentica che poggiano sulla progettazione esistenziale in direzione etica- utopica. Seguendo un’impostazione aderente al problematicismo razionalista, in grado di proiettare il soggetto- persona al di là del già dato, in un costante dialogo con gli altri, l’utopia rappresenta l’obbiettivo trascendentale verso cui tendere e consente di prefigurare (e comprendere) ciò che ancora non è.”
In questo spinta verso un “obbiettivo trascendentale” non ben precisato, se non nella misura dell’impegno, si devono leggere gli esempi portati dall’autrice. Si vuole rimarcare come gli esempi debbano essere verifiche della teoria dell’abitare etico in una progettazione esistenziale, definizioni che impongono come imperativo considerare l’intera vita degli esempi in ogni loro aspetto, tanto più che nel primo esempio si parla di una suicida. Nel capitolo “Gli enigmi della vita e il sonno della ragione” da pagina 77 è portata all’attenzione del lettore l’esperienza di ANTONIA POZZI a cavallo tra le due guerre mondiali, ma anche qua si nota, pur dopo il promettente a pagina 76 “… la consapevolezza della tragicità dell’esistenza tiene la poeta milanese sospesa su un doppio crinale, quello laico e quello cattolico.”, l’assoluta mancanza di una considerazione per l’aspetto “religioso” del vissuto di ogni essere umano; riducendo tutto ad una sola dimensione, quella esistenziale e razionalistica. In questo modo è compiuta una forzatura, perché si cerca il fine ultimo e l’etica tralasciando una mole di dati sugli stessi esempi che vengono portati a sostegno della tesi. Per altro la vita e la tragedia della Pozzi sono in questa visione parziale non pienamente contestualizzate come meriterebbero. Questa aporia esiziale che viene reiterata, in modo a tratti comico, con l’analisi della vita del poeta JEAN-BAPTISTE SIMÉON CHARDIN (1699- 1779) nel capitolo “L’abitare etico e il
silenzio estetico”, da pagina 106.
Ancora una volta l’aspetto cristiano viene ignorato, cassando di fatto l’intera problematica di un pittore di corte, qualunque esso fosse, del ‘700. Non è possibile non considerare anche solo per una seria contestualizzazione, l’aspetto religioso in Europa nel corso del ‘700, negli sviluppi dell’impegno di un pittore di corte. Queste mancanze portano alla definizione di pagina 116, che è poi la ragione di questa recensione: “Ancora, sulla scorta dell’insegnamento bertiniano, rileviamo come tale
riflessione si accosti ad uno stile esistenziale autentico e progettuale, che tenti di coniugare le istanze della ragione con i bisogni arcaici ed inconsci della vita psichica. Senza escludere i desideri e le passioni più profonde che permettono di interpretare l’esistenza attraverso il filtro di uno stile profondamente laico, ancorché intimamente religioso (pur non in senso dottrinale) e impegnato. Sulla religiosità laica dei noncredenti ecc. ecc..” che conduce a pagina 141 “… e giungere, alfine, ad affermare che l’uomo/la donna con le loro libere scelte etiche possono diventare persone (cittadini/e) capaci di prossemicità. Solo scegliendo e impegnandosi responsabilmente, sfidando la sorte, possono pensare di raggiungere persino quell’utopica meta, indefinibile eppure possibile, chiamata felicità.”
Con questo manifesto si chiude il pensiero e la linea del volume. A fronte di queste affermazione è del tutto lecito chiedersi quale sia la differenza tra la religiosità laica e la religiosità. Ripensando alla mancanza di un reale confronto critico del pensiero e dell’opera complessiva degli autori portati come esempi l’unica seria definizione di questo volume è quella di “manifesto”. Come tale è utile e di valida lettura, sapendo che non è un opera rivolta a tutti, ma solamente ad una parte che vuole portare avanti un ideale di vita. Spiace perché spesso queste parzialità non vengono messe bene in evidenza.
Francesco Raspanti, Bologna 09/04/2018.
(DiRS – GBU)

