Credere in Dio è come credere in Babbo Natale?
Credere in Dio è come credere in Babbo natale?
(G.C. Di Gaetano)
La domanda è quasi d’obbligo in clima natalizio. Ma è anche un classico, dopo la stagione del nuovo ateismo (Hitchens & Co, non dimenticando l’italiano Odifreddi). In quegli anni, infatti, un filosofo dallo spessore indiscutibile come Maurizio Ferraris scriveva un gustoso libretto dal titolo Babbo Natale, Gesù adulto. In cosa crede chi crede, Bompiani, Milano, 2006.
L’argomentazione e la mossa concettuale non sono nuove e per esse si possono scomodare precedenti sicuramente più blasonati (Kant, Hume, etc.) anche se questi non pensavano a Babbo Natale. Il problema concerne la corrispondenza reale delle credenze, in questo caso della credenza teistica: Dio esiste? Di fatto, questa è l’insinuazione, visto che non riusciamo a dimostrare la realtà di un essere supremo che chiamiamo Dio, allora una delle spiegazioni della credenza che intratteniamo su di un tale essere sta nel paragonarla a quella in Babbo Natale, della cui non esistenza siamo tutti convinti. Anzi, visto che quest’ultima credenza è legata alle fasi fanciullesche dello sviluppo di un normale bambino “cristiano”, per estensione, è probabile che la credenza nell’esistenza di Dio sia il sintomo di una condizione non adulta dell’umanità.
Anche in questo caso, se volessimo versioni più raffinate di questa spiegazione eziologica della fede in Dio potremmo scomodare i famosi maestri del sospetto (come li definì Paul Ricoeur), Marx, Fuerbach e Freud i quali, ognuno per suo conto, provarono a spiegare la ragione ultima di questa credenza (Dio esiste).
Eppure, dopo tanti sforzi, magari sollecitati dal confronto natalizio con chi ci crede in Babbo Natale (i bambini), se per caso, in questo clima natalizio ci sentiamo rimandati all’altra credenza, quella nell’esistenza di Dio, allora ci toccherà ammettere e riconoscere che essa è ancora ben presente in buona parte dell’umanità. Peter Berger, dopo aver ragionato a lungo sulla secolarizzazione intesa come rimozione o scomparsa del riferimento a Dio nella società postmoderna, ha dovuto ricredersi e, verso la fine della sua vita, ha dovuto parlare di de–secolarizzazione del mondo per spiegare il fatto che le credenze religiose, tra cui quelle teistiche, lungi dall’essere scomparse hanno dato vita a nuovi fenomeni sociali.
Tornando alla nostra ipotesi di partenza (credere in Dio è come credere in Babbo Natale?) dobbiamo segnalare la controdeduzione di coloro che vogliono ribadire la differenza (ontologica?) dei due oggetti di fede (Dio e Babbo Natale): non possiamo sradicare dalla condizione umana una simile credenza (in Dio). La tradizione apologetica cristiana lo aveva detto e vede confermato questo dato. La credenza teistica non è né insensata né irrazionale. Si direbbe che è una credenza di fondo, che appartiene a quel grappolo di credenze che per essere professate, e condivise, non necessitano del ricorse a evidenze. Ne abbiamo tante, solo se ci pensiamo e se ci atteniamo a un ragionevole criterio di “evidenza”.
Viviamo poi tempi in cui questa credenza è stata caricata di valenze che esulano dallo stretto campo d’indagine filosofica e teologica; ci sono infatti pesanti tare sociologiche che arricchiscono il bouquet di ciò che si può credere, credendo nell’esistenza di Dio: dall’armamentario sacrale della spiritualità cattolica (dal presepe al rosario), fino alla rarefatta atmosfera dei “valori cristiani” che contrapponiamo a tutte le forme di presunte invasioni culturali.
Tuttavia resta il tema da cui siamo partiti, quello della referenza reale dell’oggetto di fede: in che cosa crede chi dice di credere?
Due risposte, che sono altrettante domande.
La prima risposta si interroga su quale sia il concetto di “realtà” con il quale stiamo operando? Si deve soprattutto al filosofo Ludwig Wittgenstein l’espressione di una simile cautela. Il concetto di realtà a cui ci hanno abituato le scienze esatte può riassumere e definire in sé tutta la realtà di cui possiamo parlare? Certo, sappiamo che non troveremo mai un indirizzo corrispondente a una località geografica a cui inviare una lettera a Santa Klaus, e dunque sappiamo che i regali sotto l’albero non li mette un signore in barba bianca e cappello rosso.
Ma, e questa è la prima risposta, che altro non è se non una contro–domanda: dobbiamo per froza ragionare intorno all’esistenza di Dio negli stessi termini in cui parliamo di una realtà definita e circoscritta dal naturalismo filosofico? Attenzione, il naturalismo filosofico è cosa ben diversa dal naturalismo metodologico, quell’approccio al sapere che si confà alle nostre capacità cognitive, magari anche ricorrendo all’ipotesi di metodo secondo la quale Dio possa non esistere, mentre mettiamo l’occhio al microscopio per scrutare il microcosmo (a tal fine si consiglia la lettura di Nicola Berretta, Fede relazionale, Edizioni GBU, 2019).
Ma, ancora, è questa l’unica accezione di realtà alla quale siamo confinati?
L’altra risposta, pur prendendo in carico l’accezione naturalistica della realtà e di ciò che è reale (all’interno delle coordinate dello spazio e del tempo), contro–domanda se ci sia preclusa qualsiasi possibilità di argomentare intorno all’esistenza di Dio. Sebbene sappiamo che non potremo mai giungere a una conclusione condivisa, in quanto, come diceva Alvin Plantinga, siamo in possesso di buoni argomenti che dimostrano l’esistenza di Dio ma anche di buoni argomenti che ne dimostrano la non esistenza (a-teologia), ciò non depone a favore dell’assimilazione di Dio allo status di Babbo Natale.
Al di là dei tentativi ontologici, cosmologici, evidenzialisti, probabilistici (non dimostro l’esistenza di Dio ma giungo alla conclusione che la sua esistenza sia più probabile della sua non esistenza), cumulativi (le evidenze a favore sono cumulativamente più grandi di quelle a sfavore), questa riflessione vorrebbe suggerire che una via per ragionare intorno all’esistenza di Dio ci viene proprio con l’arrivo di Babbo Natale.
Siamo a Natale, e il Natale cristiano intende ricordare la nascita di un uomo la cui realtà nessuno discute (a parte data e circostanze); l’affermano gli Ebrei, l’ammettono i Musulmani, vedendovi qualcosa di più di un semplice individuo; la confessano i cristiani che la identificano come la manifestazione di Dio in carne.
Ebbene credo che la via della memoria storica sia l’unica vera via che ci è lasciata per affermare l’esistenza di Dio. Ciò che inizia a Natale è un’esperienza storica che si chiude la domanica di Pasqua. E questa esperienza è documentata; esistono fonti e documenti. Gesù di Nazareth è esistito e nel leggere quelle fonti non possiamo ignorare il riferimento interno che fanno alla dimensione ulteriore dell’esistenza dell’uomo Gesù: la risurrezione, le testimonianze alla risurrezione sono ciò che differenzia il contenuto della credenza nell’esistenza di Dio dal contenuto di qualsiasi altra entità di ogni ordine e grado di realtà. Paolo lo aveva intuito e lo afferma nella sua Lettera ai Corinzi.
Certo, postilla conclusiva, non disponiamo del resoconto di una tropue della CNN dall’interno del sepolcro, o, per restare a natale, della comparsa dei cori angelici nella notte di Betlemme né tanto meno della stella che conduce i sapienti di Oriente; ma siamo sicuri, in clima di negazionismo e di postverità, che anche un simile documento sarebbe stato necessario a fugare i dubbi dei complottisti?
È vero, la realtà storica della vita di Gesù come manifestazione della vita divina (1 Gv 1) non è una realtà storica “positiva” nel senso di un realismo naturalistico che influenza anche le scienze dello spirito di cui fa parte la storia. Il fervore apologetico non riuscità a replicare né Natale né Pasqua. Tant’è vero che ai credenti è promessa non la replica in laboratorio ma una nuova fase della storia (mi rivedrete tornare come mi vedete partire – Atti 1).
Tuttavia l’indagine è possibile ed è possibile anche arrivare a qualche conclusione. La storia di Gesù, quella che si tornerà a raccontare in questi giorni, grazie anche a Babbo Natale, è l’unica cosa che ci resta per tornare a punzecchiare i nostri contemporanei, ricordando loro di aguzzare la vista e guardare meglio in ciò che si appresta a manifestarsi nella stalla di Betlemme.
Vogliamo discutere di esistenza di Dio: seguiamo la stella … e vediamo dove ci porta.
Nessuno ha mai visto Dio; l’unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l’ha fatto conoscere. (Gv 1:18)


 Se gli esperti hanno opinioni diverse su quali delle fonti siano più accurate, come possiamo fidarci delle nostre traduzioni della Bibbia?
Se gli esperti hanno opinioni diverse su quali delle fonti siano più accurate, come possiamo fidarci delle nostre traduzioni della Bibbia?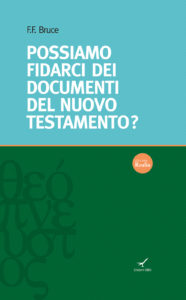 Vedi anche:
Vedi anche:
 Qualcuno ha definito l’apologetica come «la scienza e l’arte della persuasione»; questa definizione ha il merito di riunire i due principali rivoli lungo i quali si disperde l’impresa apologetica, in particolare quello della teorizzazione dei limiti, dei metodi e delle possibilità dell’apologetica che, nell’ambito delle discipline teologiche, definisce per l’apologetica i contorni di una vera e propria scienza; dall’altro lato il rivolo richiamante l’ambientazione reale e concreta della dinamica apologetica che emerge e si evidenzia nei contesti dialogici, dove è necessario una competenza comunicativa ed empatica (un’arte).
Qualcuno ha definito l’apologetica come «la scienza e l’arte della persuasione»; questa definizione ha il merito di riunire i due principali rivoli lungo i quali si disperde l’impresa apologetica, in particolare quello della teorizzazione dei limiti, dei metodi e delle possibilità dell’apologetica che, nell’ambito delle discipline teologiche, definisce per l’apologetica i contorni di una vera e propria scienza; dall’altro lato il rivolo richiamante l’ambientazione reale e concreta della dinamica apologetica che emerge e si evidenzia nei contesti dialogici, dove è necessario una competenza comunicativa ed empatica (un’arte).
