di Tonino Mele
Il conflitto israelo-palestinese, non solo riesce a contrapporre persone sul campo di battaglia, nei social media e nelle piazze, ma persino nella teologia, che per vocazione dovrebbe più mirare alla pace tra i popoli. Assistiamo così a prese di posizione unilaterali e selettive da parte di cristiani che parteggiano o per i palestinesi o per Israele ed entrambi si richiamano a Cristo e alla Bibbia. È evidente che questa situazione apre un terzo fronte, che è apologetico e vuol preservare la Bibbia da richiami di parte che mettono in dubbio la sua unità ed integrità. Se la Bibbia può essere tirata per la giacchetta da una parte e dall’altra, che Bibbia è? La teologia, più che creare steccati, deve poter creare ponti tra percezioni unilaterali delle verità bibliche, perché siamo uomini, quindi imperfetti e bisognosi dell’altro per progredire verso la perfezione. Ed è perciò apprezzabile il tentativo di Yuri Mark, un ricercatore indipendente, che in un suo articolo ha riflettuto sul tema: “Le teologie contrastanti della terra tra ebrei messianici e cristiani palestinesi: è possibile un dialogo teologico riconciliatorio?”, che vogliamo di seguito sintetizzare e al quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti.
Esso è reperibile in rete: http://reflections.eeit-edu.info/article/download/330290/320190.
In questo studio Yuri Mark cita autori diversi, sia cristiani ebrei messianici che cristiani palestinesi, spaziando dall’escatologia premillenarista dispensazionista e storica a quella amillenarista, nel tentativo di indagare punti di contatto che aiutino i cristiani ad affrontare con una voce sola il dramma in atto tra israeliani e palestinesi, soprattutto dopo il 7 ottobre 2023. Egli parte sostenendo una lunga tradizione apolitica della chiesa cristiana, che nel conflitto israelo-palestinese viene confermata dalla posizione apolitica dei pionieri del premillenarismo dispensazionalista, ma muta quando esso si salda col Sionismo politico, al quale si contrappone il discorso cristiano palestinese che “è caratterizzato da una forte preoccupazione etica e politica”.
Sulla base di questa sintesi iniziale, egli inizia con teologi messianici cristiani come Arnold Fruchtenbaum autore di Israelology: The Missing Link in Systematic Theology e David Stern autore del Messianic Jewish Manifesto, premillenarista dispensazionalista il primo e premillenarista storico il secondo, i quali pur occupandosi nei loro scritti molto di Israele nel piano di Dio, sia nel passato che nel futuro, poco hanno detto su Israele nel presente, ed in particolare “non sono riusciti a riflettere sulle implicazioni morali-politiche per Israele o a indagare l’identità ebraica messianica israeliana rispetto alle loro controparti arabe cristiane, e non hanno ritenuto questo un compito teologico urgente”. La loro posizione rimane dunque fondamentalmente apolitica e, solo in via eccezionale, fanno dei riferimenti alla situazione politica attuale.
E questo è più che mai vero per il premillenarismo dispensazionalista, che spesso è stato accusato di essere “politicizzato” e persino “razzista”. Citando Judith Mendelsohn Rood e Paul Rood, autori dell’articolo “Is Christian Zionism Based on Bad Theology?”, Mark scrive che i primi dispensazionalisti “apprezzavano chiaramente i diritti e le speranze degli arabi nella Palestina mandataria” e seguivano “un’etica di giustizia compassionevole”. Ed aggiunge che è quando “il dispensazionalismo si è sposato con il sionismo politico” che ha prodotto “una nuova forma politicizzata del sionismo cristiano, che differiva notevolmente sia dal precedente sionismo cristiano, sia dal dispensazionalismo ‘normativo’ di un secolo fa”. In effetti, chi conosce bene il premillenarismo dispensazionalista di Fruchtenbaum sa che non può essere accusato di fomentare la ricostituzione militare del cosiddetto Grande Israele perché, come gli ebrei messianici (non cristiani), egli non si aspetta che ciò accada ora, ma solo quando il Messia sarà venuto ed è cosa che realizzerà lui.
Mark prosegue citando il teologo amillenarista Richard Nichol, che in un articolo titolato “Are We Really at the End of the End Times? A Reappraisal”, esorta a non concentrarsi sulla fine del mondo, ma a occuparsi della responsabilità morale attuale del cristiano nella società, senza tuttavia occuparsi in modo specifico in tale articolo del conflitto israelo-palestinese. Cita poi il docente ebreo messianico americano, Mark Kinzer, il quale “riconosce l’azione di Dio nel ristabilimento di una casa ebraica nella terra di Israele, ma distingue tra la vita nazionale, da un lato, e lo Stato ‘che ne ordina gli affari’, dall’altro”. Per Kinzer, autore del libro Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen, “lo Stato è solo uno strumento necessario e non un obiettivo in sé e per sé”. Ciò significa che “lo Stato ha un carattere preliminare e provvisorio in relazione al Regno messianico, la cui venuta spezzerà l’ordine di questo mondo (e dello Stato di Israele) così come lo conosciamo”. Per cui, secondo Kinzer, Israele può fare concessioni territoriali, se ciò è opportuno dal punto di vista politico-sociale, ed è su questo piano che anche Arnold Fruchtenbaum legittimava l’abbandono di Gaza ai palestinesi nel 2005. Kinzer non crede che gli ebrei messianici [cristiani] debbano approvare tutto quello che fa lo Stato israeliano, anche se non possono avere una posizione neutrale nel conflitto israelo-palestinese, consci del fatto che la loro presenza nella terra promessa è un miracolo dello Spirito, che “lo spirito dell’antisemitismo è identico allo spirito dell’anticristo” e che l’antisionismo può diventare un “mantello socialmente accettabile per l’antisemitismo”.
Mark conclude la sua carrellata di teologi messianico cristiani, citando il teologo britannico Richard Harvey, autore di Towards a Messianic Jewish Theology of Reconciliation. The Strategic Engagement of Mes sianic Jewish Discourse in the Israeli-Palestinian Conflict, il quale sostiene un’Israelologia che continua a “sviluppare ‘la sua comprensione di Israele nel presente, come popolo di Dio e come popolo come gli altri… per integrare efficacemente fede, identità e vita quotidiana nel contesto politico ed escatologico’ ed elaborare ‘una teologia pratica di riconciliazione con i cristiani arabi e la popolazione araba alla luce del conflitto israelo-palestinese’”. Quindi, una teologia di Israele, con lo sguardo rivolto al suo futuro glorioso, ma con un occhio attento al presente, da vivere nel segno della riconciliazione e della pace con il mondo arabo. Ma per poter fare ciò bisogna conoscere le istanze dell’altra parte ed è ciò su cui, da questo punto in poi si concentra lo studio in oggetto.
Munther Isaac, un arabo palestinese residente in Cisgiordania e professore al Bethlehem Bible College è il primo teologo cristiano palestinese che viene preso in considerazione, autore del libro From Land to Lands, la cui tesi principale è che “il concetto biblico di terra è passato da particolare nell’Antico Testamento a universale dopo l’evento di Gesù”, il quale è diventato l’epicentro di questa nuova terra promessa, che non è più la terra d’Israele ed Israele stesso, ma tutto il mondo e i credenti in Cristo di ogni nazione. Per cui “la terra d’Israele ha perso il suo particolare ruolo teologico” redentivo ed anche “Israele è ora universalizzato nel suo Messia”. Pur riconoscendo che la chiesa è innestata nell’“ulivo” di Israele, che c’è continuità tra l’Israele biblico e la chiesa e che Dio non ha rigettato Israele, ciò non evita alla teologia di Isaac la critica di essere una sorta di teologia della sostituzione. Egli si oppone sia alle politiche sioniste che a quelle musulmane che si basano sulle rivendicazioni esclusive della terra “dal fiume al mare” volendola dividere e parla invece di una terra da condividere fra tutti i suoi abitanti e le sue diverse etnie in modo equo e con gli stessi diritti. Egli mette in guardia dall’idolatrare la terra e si richiama alle grandi ed universali virtù cristiane della giustizia, l’uguaglianza, la riconciliazione e la fratellanza. Il punto nevralgico della teologia di Isaac, che non può essere accettato dalla controparte ebraica e messianica è che de-teologizza del tutto la terra promessa ad Israele ed il popolo ebraico e disconosce la priorità data dal Signore a questo popolo, finendo per promuovere un concetto di giustizia e di uguaglianza diverso e pregiudiziale.
Sulla stessa lunghezza d’onda di Isaac si colloca Yohanna Katanacho, un altro teologo evangelico palestinese, autore del libro The Land of Christ: A Palestinian Cry, il quale afferma che Cristo in quanto compimento della promessa fatta ad Abramo è diventato il proprietario ultimo della terra dopo l’inaugurazione del Nuovo Patto, inoltre considera problematica l’identificazione dell’attuale Israele con l’Israele biblico e contesta la tesi che Ezechiele 37 ed il ritorno degli ebrei in Palestina, si adempia prima dell’era messianica futura. Ma in particolare, Katanacho è uno dei fautori di Kairos Palestine, un documento che si basa su una lettura “ecumenica post liberale teopolitica” della Bibbia e vuol dare una valutazione teologico morale del conflitto israelo-palestinese. Partendo dal fatto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, considera ogni atto di disumanizzazione delle persone come peccato e denunzia come tali “il muro di separazione, i posti di blocco e le politiche di accaparramento delle terre derivanti dall’occupazione” israeliana. Contro ogni ipoteca escatologica o politica della terra chiamata significativamente “Palestina”, il documento promuove tale terra come luogo di fede, luogo di pace, luogo di riconciliazione e luogo di speranza e delinea come principi della resistenza (palestinese) “l’amore per il nemico, la giustizia, la dignità umana, la non violenza, la protezione dei bambini, la difesa degli oppressi, una soluzione politica equa e giusta per la condivisione della terra”. Anche con Katanacho ed il documento Kairos il punto critico rimane lo stesso: si fa un discorso a tratti molto condivisibile, perché umano e cristiano, ma che si fonda sulla de-teologizzazione di Israele e della terra, che si configura come una delegittimazione dell’Israele attuale e delle attese profetico-messianiche, verso le quali manifesta una certa refrattarietà.
Un altro coautore di Kairos Palestine, Mitri Raheb, storico e pastore evangelico luterano, autore del libro Faith in the Face of Empire, assume una posizione ancora più radicale contro lo Stato sionista e le teologie basate su Israele. Egli considera l’attuale Stato di Israele una pura finzione storica e politica, frutto di un’ideologia razzista, “un progetto coloniale di tipo occidentale che ha trasformato gli stranieri in nativi e i nativi in stranieri”, ma ne prefigura la caduta ed allora il popolo palestinese erediterà la terra. Ed a tal fine propone sia una lettura palestinese della Bibbia, dove i palestinesi sono i veri destinatari delle promesse, ma anche una sorta d Teologia della Liberazione creativa, fatta non di violenza, ma di una resistenza che esprime le paure del popolo palestinese attraverso “storie, poesia, pittura, teatro, musica e danza, creando così una cultura di speranza e vita, e non di vittimismo e morte”. Indubbiamente il suo approccio creativo alla protesta è interessante, se non altro molto meno cruento del terrorismo palestinese, ma è importante che non si rappresentino impressioni soggettive falsate dall’ideologia in cui si è cresciuti, ma vi sia una creativa ricerca della verità. E certamente identificare i palestinesi odierni con gli ebrei dell’Israele biblico o usare in modo anacronistico il termine “palestinese” per dire che Gesù era “un palestinese vissuto in Palestina”, è cosa che neppure l’arte può legittimare come vero.
Lo stesso anacronismo si può osservare in Naim Ateek, un teologo della liberazione palestinese, autore del libro A Palestinian Theology of Liberation, nel quale pure troviamo “l’associazione dell’Israele dell’Antico Testamento con il popolo della Palestina e degli odierni cristiani palestinesi con l’Israele dell’Antico Testamento, negando al contempo agli ebrei non mediorientali qualsiasi connessione storica e genetica con l’Israele biblico”, che Mark definisce una “inquietante negazione delle identità”. Ateek arriva a creare un pericoloso canone nel canone quando sostiene che “tutto ciò che nella Bibbia non corrisponde allo standard di Cristo non è autorevole”, un taglio che ricorda l’eresia marcionita.
È evidente che in questo modo non si va da nessuna parte nel già arduo percorso della pace. In particolare, Mark conclude il suo studio denunciando l’ambito troppo ampio delle teologie della Liberazione, le quali dovrebbero interessarsi anzitutto della pace tra cristiani palestinesi e cristiani ebrei messianici, piuttosto che occuparsi dell’ambito più ampio della pace tra ebrei e arabi. Le teologie divergenti e contrastanti viste fin qui dimostrano quanto sia importante trovare un punto d’incontro tra i cristiani stessi coinvolti nel conflitto tra i rispettivi popoli. Poi Mark propone di identificare i vari ostacoli alla pace: 1. Un approccio identitario nazionale che offusca l’identità in Cristo di entrambi che è la medesima; 2. Mancanza di una visione teologica della vita comune, che non persegue una comunione scevra da ingiustizie, paure e sfiducia; 3. La resistenza interna delle frange più estremiste che impedisce un approccio equilibrato e disallineato; 4. Mancanza di empatia, cioè di compassione ed incapacità di porsi nei panni dell’altro.
La proposta che Mark avanza è questa: “Le parti dovrebbero essere disposte a impegnarsi a rivisitare le credenze al centro dei loro sistemi teologici. I palestinesi potrebbero voler mettere in discussione la loro convinzione che Israele (sebbene sia estremamente difficile definire o identificare ‘Israele’) sia completamente estraneo al piano di Dio così come è svelato nel Nuovo Testamento (questo potrebbe avere o meno implicazioni per la teologia cristiana palestinese della terra). Gli studiosi ebrei messianici potrebbero volersi porre una domanda difficile: ‘Crediamo veramente che, per Dio, l’esistenza ebraica nella terra abbia un valore superiore a quello di chiunque altro?’. E se una teologia della riconciliazione ebraico-palestinese iniziasse a prendere forma, sarebbe un miracolo simile a quello di Cristo, ‘che di due ha fatto un popolo solo, abbattendo nella sua carne il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia’ (Efesini 2:14)”. In altre parole, da un lato non si deve de-teologizzare il ruolo di Israele e dall’altro si deve vivere questo ruolo in dipendenza dal Signore, con un’etica giusta e responsabile.
Per quel che ci riguarda, riteniamo che, seppur Dio ami anche i palestinesi e Cristo è morto anche per loro, il Signore ha assegnato un ruolo speciale ad Israele e dobbiamo prenderne atto se non vogliamo aprire un terzo fronte, quello contro Dio. Per questo ruolo speciale Israele è considerato più responsabile e per questo deve avere un atteggiamento giusto, se anch’esso non vuol entrare in conflitto con Dio. Una teologia di pace non deve negare il ruolo di Israele nel piano di Dio, sia passato che futuro, ma deve far leva su questo ruolo per responsabilizzarlo alla pace nel presente. D’altro canto, poiché la pace si fa in due, anche i palestinesi devono cooperare responsabilmente per la pace, senza minarla con atti di boicottaggio. E soprattutto loro, che hanno sviluppato teologie che de-teologizzano la terra ed invitano a non idolatrarla, dovrebbero desistere dall’ideologia esclusivista “dal fiume al mare”.
Tonino Mele è responsabile di una chiesa evangelica a Siniscola (NU)
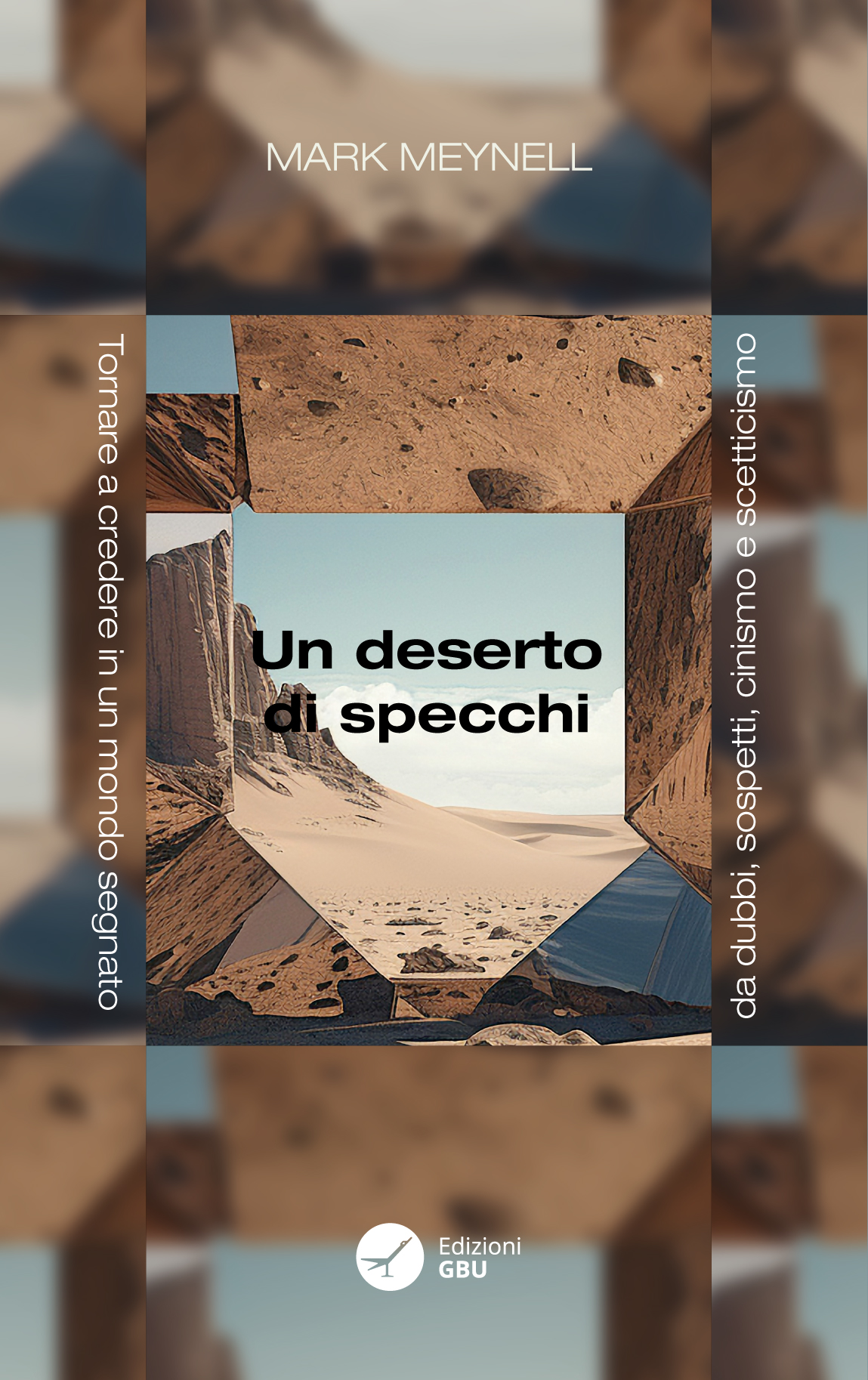 so, a ignoranza o a qualcuna delle miriadi di diagnosi e medicine inadeguate di cui l’umanità è stata prodiga, bensì a una ribellione morale di fondo contro la fonte stessa della nostra umanità e al nostro rifiuto della benevola autorità di Dio nel suo mondo. Questa è la radicale analisi biblica del peccato. Qualsiasi cosa di inferiore è superficiale e non è in grado di dare senso alla realtà così come la conosciamo. Per me ha senso che il Dio creatore di un tale, splendido mondo debba, per amore, scegliere di non distruggerlo ma di redimerlo per mezzo di Gesù di Nazaret e della sua incarnazione, della sua morte, risurrezione e ascensione. Ha senso, infine, che dopo avere promesso e realizzato tutto questo che troviamo nella storia biblica Dio non lasci incompiuto il progetto (non lo farà); farà invece terminare la storia con la piena restaurazione del creatopreconizzata da Isaia, da Paolo e da Giovanni di Patmos. È questa storia ad avere senso, in quanto è la storia evangelica della missione di Dio, che guida la nostra missione nel mondo. È questa la storia, questa la persona di cui possiamo fidarci, in un mondo in cui la fiducia è soverchiata dal cinismo, dagli abusi, dall’ironia e dalle teorie cospirazioniste. La critica straordinariamente sensibile e documentata mossa da Mark Meynell alla nostra cultura mette in luce come la perdita di fiducia a ogni livello della società rifletta la perdita di qualsiasi capacità di «dare un senso» alla «vita, all’universo e a tutto quanto»; il che è, a sua volta, il prodotto del rifiuto deliberato di qualsiasi narrazione capace di garantire un tale “senso” universale, all’indomani dell’evidente fallimento della “narrazione” della modernità. Evidentemente, possiamo fidarci soltanto se siamo convinti dell’affidabilità sia della storia offerta sia di colui che ci invita a prendervi parte e della capacità, in qualche modo, di garantire un lieto fine. La terza parte del presente volume presenta in modo convincente la tesi secondo cui la narrazione evangelica di tutta la Bibbia offre proprio una tale sicurezza, una sofferta parola di speranza in un «deserto di specchi», un invito a tornare a credere e una base motivazionale per una missione biblicamente radicata, autentica e umile, nelle sue sicurezze, per il popolo di Dio nel mondo di Dio.
so, a ignoranza o a qualcuna delle miriadi di diagnosi e medicine inadeguate di cui l’umanità è stata prodiga, bensì a una ribellione morale di fondo contro la fonte stessa della nostra umanità e al nostro rifiuto della benevola autorità di Dio nel suo mondo. Questa è la radicale analisi biblica del peccato. Qualsiasi cosa di inferiore è superficiale e non è in grado di dare senso alla realtà così come la conosciamo. Per me ha senso che il Dio creatore di un tale, splendido mondo debba, per amore, scegliere di non distruggerlo ma di redimerlo per mezzo di Gesù di Nazaret e della sua incarnazione, della sua morte, risurrezione e ascensione. Ha senso, infine, che dopo avere promesso e realizzato tutto questo che troviamo nella storia biblica Dio non lasci incompiuto il progetto (non lo farà); farà invece terminare la storia con la piena restaurazione del creatopreconizzata da Isaia, da Paolo e da Giovanni di Patmos. È questa storia ad avere senso, in quanto è la storia evangelica della missione di Dio, che guida la nostra missione nel mondo. È questa la storia, questa la persona di cui possiamo fidarci, in un mondo in cui la fiducia è soverchiata dal cinismo, dagli abusi, dall’ironia e dalle teorie cospirazioniste. La critica straordinariamente sensibile e documentata mossa da Mark Meynell alla nostra cultura mette in luce come la perdita di fiducia a ogni livello della società rifletta la perdita di qualsiasi capacità di «dare un senso» alla «vita, all’universo e a tutto quanto»; il che è, a sua volta, il prodotto del rifiuto deliberato di qualsiasi narrazione capace di garantire un tale “senso” universale, all’indomani dell’evidente fallimento della “narrazione” della modernità. Evidentemente, possiamo fidarci soltanto se siamo convinti dell’affidabilità sia della storia offerta sia di colui che ci invita a prendervi parte e della capacità, in qualche modo, di garantire un lieto fine. La terza parte del presente volume presenta in modo convincente la tesi secondo cui la narrazione evangelica di tutta la Bibbia offre proprio una tale sicurezza, una sofferta parola di speranza in un «deserto di specchi», un invito a tornare a credere e una base motivazionale per una missione biblicamente radicata, autentica e umile, nelle sue sicurezze, per il popolo di Dio nel mondo di Dio.
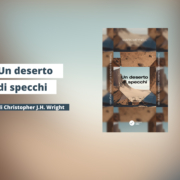
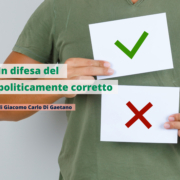
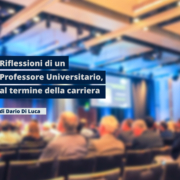

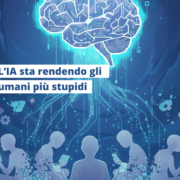
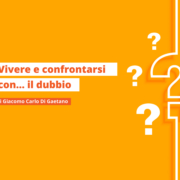
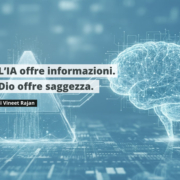


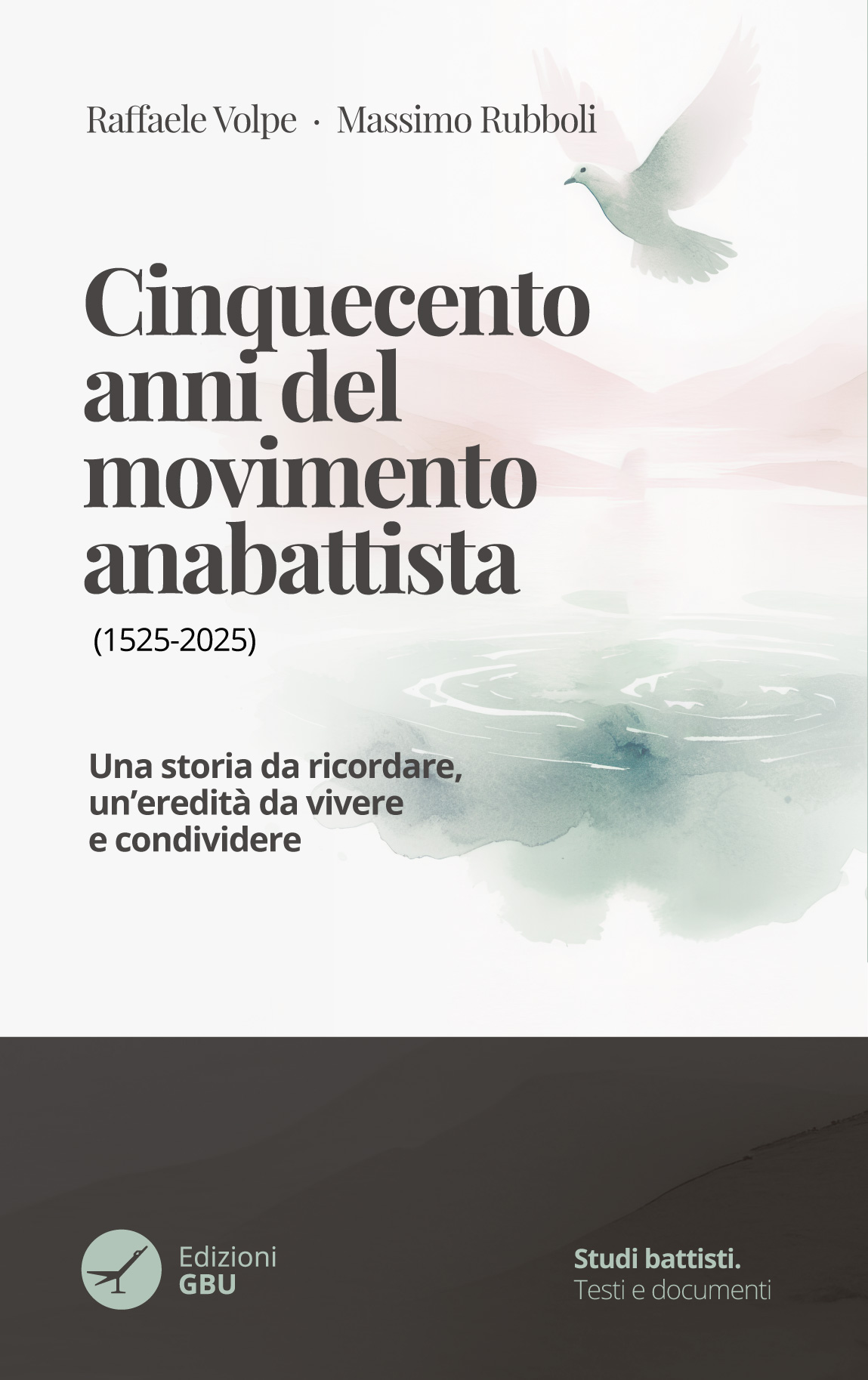 lle nostre mancanze. Aiutaci a esserti fedeli, anche se questa fedeltà ci costerà il prezzo della croce. È nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, che ti prego. Amen». Seguì un lungo silenzio e io tornai a sedermi. L’eco delle ultime parole di Zwingli, dopo la disputa sul battesimo che si era tenuta qualche giorno prima, ancora risuonava nelle mie orecchie: «Che intenzioni avete? Volete dividere la Chiesa?». George Blaurock si alzò. Si aggiustò alla meno peggio nel suo enorme cappotto blu e, con voce sonante – non a caso era chiamato “Giorgio il forte” –, scandendo ad una ad una le sue parole, disse: «Ma quali dubbi? Cosa c’è di più chiaro? Trovatemi un solo passo nella Bibbia in cui il battesimo viene amministrato a un bambino appena nato. Che cosa ci insegnano le parole di Cristo: Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato (Mc 16:16)? Io stasera non torno a casa se prima non sarò stato battezzato».Si sentirono più voci accavallarsi: sì, è vero, ha ragione il fratello George; sì, è proprio così che Cristo dice; ben detto fratello… «Silenzio», dissi, «silenzio», ripetei «dobbiamo esprimerci tutti e soltanto quando tutti avranno preso la parola, decideremo cosa fare». Anna, la più anziana del gruppo, parlò per prima: «Noi non possiamo ignorare il comandamento di Gesù Cristo. Io sono pronta. E sono certa che anche tutti gli altri, come me, lo sono. Vero?». Non aveva ancora pronunciato per intero la parola ‘vero’ che si era girata prima alla sua sinistra e da lì velocemente aveva guardato tutti noi negli occhi fino a fermarsi alla sua destra, lì dove era seduto Johann Broetli.Broetli si sentì interpellato da quello sguardo di Anna e disse la sua. Gli altri lo seguirono. Parlarono tutti e tutti furono concordi. Mi alzai in piedi nuovamente, sentii una misteriosa forza nei muscoli delle mie gambe, chiesi a Felix Mantz di portarmi una brocca d’acqua e un catino. Ci inginocchiammo e pregammo tutti, chiedendo a Dio di aiutarci a compiere il suo volere e ad avere misericordia su di noi. Eravamo tutti consapevoli che avremmo sofferto a causa di quel gesto. Dopo la preghiera, Blaurock si alzò e mi chiese di essere battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella sera fummo in quindici a battezzarci e da quella sera nulla fu più come prima.
lle nostre mancanze. Aiutaci a esserti fedeli, anche se questa fedeltà ci costerà il prezzo della croce. È nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, che ti prego. Amen». Seguì un lungo silenzio e io tornai a sedermi. L’eco delle ultime parole di Zwingli, dopo la disputa sul battesimo che si era tenuta qualche giorno prima, ancora risuonava nelle mie orecchie: «Che intenzioni avete? Volete dividere la Chiesa?». George Blaurock si alzò. Si aggiustò alla meno peggio nel suo enorme cappotto blu e, con voce sonante – non a caso era chiamato “Giorgio il forte” –, scandendo ad una ad una le sue parole, disse: «Ma quali dubbi? Cosa c’è di più chiaro? Trovatemi un solo passo nella Bibbia in cui il battesimo viene amministrato a un bambino appena nato. Che cosa ci insegnano le parole di Cristo: Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato (Mc 16:16)? Io stasera non torno a casa se prima non sarò stato battezzato».Si sentirono più voci accavallarsi: sì, è vero, ha ragione il fratello George; sì, è proprio così che Cristo dice; ben detto fratello… «Silenzio», dissi, «silenzio», ripetei «dobbiamo esprimerci tutti e soltanto quando tutti avranno preso la parola, decideremo cosa fare». Anna, la più anziana del gruppo, parlò per prima: «Noi non possiamo ignorare il comandamento di Gesù Cristo. Io sono pronta. E sono certa che anche tutti gli altri, come me, lo sono. Vero?». Non aveva ancora pronunciato per intero la parola ‘vero’ che si era girata prima alla sua sinistra e da lì velocemente aveva guardato tutti noi negli occhi fino a fermarsi alla sua destra, lì dove era seduto Johann Broetli.Broetli si sentì interpellato da quello sguardo di Anna e disse la sua. Gli altri lo seguirono. Parlarono tutti e tutti furono concordi. Mi alzai in piedi nuovamente, sentii una misteriosa forza nei muscoli delle mie gambe, chiesi a Felix Mantz di portarmi una brocca d’acqua e un catino. Ci inginocchiammo e pregammo tutti, chiedendo a Dio di aiutarci a compiere il suo volere e ad avere misericordia su di noi. Eravamo tutti consapevoli che avremmo sofferto a causa di quel gesto. Dopo la preghiera, Blaurock si alzò e mi chiese di essere battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella sera fummo in quindici a battezzarci e da quella sera nulla fu più come prima.