di Marcello Favareto
La lunga scia di attentati di matrice islamista in Europa nonché l’orrore del 7 Ottobre in Israele e la conseguente distruzione nella striscia di Gaza mantengono alta l’attenzione sulla presenza degli islamici di casa nostra e sul rapporto tra religione islamica e civiltà occidentale, sulla compatibilità degli insegnamenti del Corano con le società laiche occidentali.
Nel tempo, qua e là si sono registrate manifestazioni di musulmani con i cartelli “Not in my name”, forse segni di un ripensamento e per l’affermazione di un islam pacifico con la distinzione dai fondamentalisti violenti, dichiarati “sedicenti islamici” o addirittura “non islamici”.
Ci sono enormi, forse insormontabili difficoltà in questa operazione. Gli studiosi (Colin Chapman, p. 60) distinguono in proposito tra un Islam popolare, un Islam liberale e modernista e un Islam tradizionalista e ortodosso. Tuttavia nel decidere, ammesso che lo si possa fare, quale sia l’Islam con il quale preferiremmo interagire vorrei fare qualche considerazione che riguarda anche il cristianesimo.
Guerra santa e/o convivenza pacifica
Il primo punto che dobbiamo dirimere è l’alternativa tra guerra santa e/o convivenza pacifica. È possibile una riforma dell’Islam che vada nella direzione della seconda alternativa? È possibile leggere il Corano in maniera diversa da come è stato interpretato e applicato finora? Come si possono conciliare la jihad con un islam pacifico?
Ho deciso di rendermene conto direttamente e mi sono letto tutto il Corano, con un’attenzione particolare all’atteggiamento che i fedeli devono avere verso gli infedeli.
Ecco alcune Sure che parlano esplicitamente di questo.
 Guerra santa
Guerra santa
Sura II
190-193 “Combattete i vostri nemici nella via di Dio e non uscite mai da essa. Sappiate che Egli non ama chi esce dal Retto Sentiero. Uccideteli ovunque li incontrate e cacciateli via da dove essi hanno cacciato voi: subire passivamente una persecuzione è cosa peggiore dell’incontrare la morte. Ma evitate di ucciderli vicino alla Santa Casa, salvo che non siano essi i primi ad attaccarvi. In questo caso vi è lecito ucciderli e la morte sarà la ricompensa della loro iniquità. Se però i vostri nemici depongono le armi, allora anche voi deponetele e perdonate loro. Dio, infatti, è il Clemente e il Misericordioso! Combattete sino a che i Credenti non saranno più perseguitati e la sola religione sarà quella di Dio. Da quel momento i vostri nemici saranno i miscredenti e gli iniqui.”
Sura III
127-128 “Il vostro Signore vi renderà vittoriosi e ciò per uccidere ed umiliare i miscredenti, i quali saranno così i perdenti in questa e nell’altra vita . Lascia, Mohammad, che Dio accetti il loro pentimento o che li punisca, a Suo piacimento. In verità essi sono degli empi e degli iniqui!”
Sura IV
89 “I miscredenti vorrebbero che foste come loro, ma voi non scegliete fra di essi i vostri amici a meno che non abbiano riconosciuto la loro colpa e fatto ritorno sul Retto Sentiero. Ma se dovessero ritornare nella loro precedente condizione, allora vi è lecito prenderli ed ucciderli, ovunque si trovino.”
Ma subito dopo è scritto anche:
90-91 “Tra i miscredenti abbiate ad amici o a protettori solo quelli che appartengono a gente con cui esiste un patto di alleanza …. Se il vostro Signore avesse voluto, essi avrebbero prevalso su di voi, per cui se restano neutrali, non vi combattono o vi offrono la pace, non è lecito che voi li combattiate e, se lo farete, la vostra lotta non sarà sulla Via di Dio. Troverete altra gente che vorrà vivere in pace con voi, ma che coglierà in seguito ogni occasione per nuocervi. Accettate di buon grado la loro pace, ma se accadrà che essi non osservino le promesse e vi attacchino, allora combatteteli ed uccideteli, ovunque li troviate. Dio vi rende lecito un simile comportamento!”
93 “Ma per chi uccide intenzionalmente un Credente la punizione sarà il fuoco dell’Inferno ed in quel luogo troverà la sua eterna dimora.”
Sura IX
5 “O voi che credete! Osservate il patto concluso con gli idolatri, ma, allo spirare dei mesi sacri, combatteteli, ovunque li troviate. Non date loro tregua ed uccidete quanti di essi cadranno nelle vostre mani. Ma se quella gente si pentirà, crederà in Dio e nel giorno del Giudizio, osserverà la preghiera e pagherà la Tassa, allora cessate di combatterla. In verità Dio è il Clemente ed il Misericordioso!”
Sura XXXIII
60-62 “Se gli ipocriti, i miscredenti ed i sediziosi di Medina non cesseranno le loro provocazioni, ti sia lecito, Mohammad, muovere contro quella gente ed infliggere ad essi la giusta punizione. Essi sono dei Maledetti da Dio, per cui debbono essere uccisi dai Credenti allo stesso modo che, in passato, fu fatto – per Ordine Suo – nei confronti di altri negatori.”
Sura LIX
2 “E’ Lui che, chiamando alla Guerra Santa i Credenti, ha cacciato dalle loro dimore quanti, tra la Gente del Libro, rifiutarono di credere alle tue parole, Mohammad.”
Sura CX
1-2 “O Inviato! Quando, coll’aiuto di Dio, voi otterrete il desiderato trionfo sugli idolatri, allora tutti entreranno nella nostra religione.”
Mi sembra che i versetti siano, purtroppo, piuttosto espliciti.
Convivenza pacifica
Però, per rispetto della verità, dobbiamo anche riconoscere che coloro che difendono l’islam pacifico e rifiutano il terrorismo non raccontano frottole e fanno riferimento ad altri versetti. Tra i più noti possiamo ricordare:
Sura II
62 “In verità, coloro che, Ebrei, Cristiani e Sabei, credono in Dio e nel Giorno del Giudizio e compiono le buone opere, avranno la ricompensa presso il loro Signore. Essi nulla avranno da temere da lui e non vivranno nella tristezza.”
256 “Non vi dà alcuna costrizione nella Fede, poiché il Retto Sentiero si distingue da solo dal Sentiero dell’Errore. …”
Questo versetto viene spesso citato (v. anche ciò che ha scritto il filosofo francese nel testo precedente) ed enfatizzato più di quanto non sembri nel suo contesto.
Sura III
3-4 “Egli ha fatto scendere su di te, Mohammad, il Libro di Verità, a conferma delle precedenti Rivelazioni. Egli è colui che ha fatto scendere la Torah e il Vangelo, affinché quei Libri fossero guida per i Credenti. …”
20 “… Dì poi alla gente del Libro ed agli idolatri: “Volete voi abbracciare l’Islam?” Se lo faranno, i loro passi percorreranno il Retto Sentiero, ma se rifiuteranno di farlo, tu lasciali al loro destino. Tuo compito è solo quello di mostrare i Segni di Dio a chi è in grado di coglierli. Il tuo Signore osserva ogni azione umana.”
64 “Dì, Mohammad, alla Gente del Libro: “Cerchiamo di trovare una soluzione che ci accomuni. Noi adoriamo un Unico Dio e non abbiamo altro Dio all’infuori di Lui.”
113-115 “Non tutta la Gente del Libro appartiene al numero dei miscredenti. Nel suo seno vi è infatti una comunità di Credenti che prega continuamente il suo Signore, prosternandosi in adorazione nelle ore della notte. Essi credono in Dio e nel giorno del Giudizio, amano la Verità, rifuggono dall’Errore e compiono le buone opere. Essi sono Virtuosi e Timorati di Dio. Il vostro Signore li ricompenserà, poiché Egli premia chi fa la Sua Volontà e Gli si mostra ubbidiente.”
Sura V
13-14 “In seguito gli Ebrei violarono questo patto e Noi li maledicemmo, indurendo i loro cuori. Fu così che essi falsarono il significato delle parole del loro Libro, giungendo fino a dimenticarne una parte: solo un piccolo numero evitò una simile miscredenza. Sii dunque benevolo, Mohammad, verso questi Credenti, perché Dio ama chi crede in Lui.
Noi stringemmo pure un Patto di Alleanza con i Cristiani, ma anche essi hanno dimenticato una parte del loro libro. Per punirli di ciò Dio ha fatto sorgere tra di essi le divisioni e l’odio perdurerà nel loro seno sino al Giorno del Giudizio.”
Ironia della sorte Maometto non poteva sapere quale drammatica divisione sarebbe emersa pochi anni dopo la sua morte tra i suoi seguaci: ancora oggi Sunniti e Shiiti si odiano profondamente.
32 “Fu a causa di questo delitto [Caino] che Noi dicemmo ai figli di Israele che l’uccisione di un essere umano, salvo il caso di un errore o di una disgrazia, sarebbe stato da noi considerato come un delitto contro l’intera umanità.”
Questo è il versetto che viene spesso citato quando si vuole dimostrare che l’islam è pacifico e che il Corano condanna quindi gli attentati e gli assassinii.
46-48 “Noi mandammo Gesù, Figlio di Maria, a confermare il Libro che già avevamo loro dato. Demmo a lui il Vangelo, in cui vi sono Luce e Guida, affinché i Virtuosi lo seguissero e credessero nelle sue parole.
Giudichino perciò i Cristiani secondo il Vangelo, poiché solo i miscredenti e gli iniqui prescindono dalla Parola di Dio nel dare i loro giudizi.
E su di te, Mohammad, facemmo scendere il Libro di Verità, a conferma delle Rivelazioni da Noi fatte agli Inviati che ti hanno preceduto. Giudica dunque Ebrei e Cristiani alla luce del Libro e le passioni non offuscheranno il tuo giudizio. In verità, Dio ha assegnato ad ognuno una via da seguire, mentre, se avesse voluto, Egli avrebbe fatto degli uomini una sola comunità con una sola Fede. Ma ciò non è , perché Dio vuole mettervi alla prova. Gareggiate dunque nel compiere buone opere, e nel Giorno del Giudizio tutti sarete radunati davanti a Lui. In quel giorno conoscerete da Dio le cose che vi hanno tenuti divisi su questa terra.”
65-66 “In verità, quanti tra la Gente del Libro crederanno ed agiranno da Virtuosi, avranno il perdono del loro Signore e saranno da Lui accolti nel Suo Paradiso.
In verità, se essi metteranno in pratica la Torah ed il Vangelo e quanto Dio ha rivelato loro, i Cieli e la Terra saranno benevoli verso di loro. Fra la Gente del Libro vi è chi è Credente, ma la maggior parte non crede e non compie le buone opere!”
E ancora una piccola chicca, sorprendente rispetto all’immagine dell’islam che riceviamo oggi.
82 “Tu troverai negli Ebrei e negli Idolatri i più accaniti nemici dei Credenti, mentre tra i Cristiani troverai i più sicuri amici. Questo avviene in quanto tra i Cristiani vi sono sacerdoti e monaci che servono Dio in umiltà e la superbia non regna tra chi segue Gesù, Figlio di Maria.”
Non pretendo certo di interpretare il Corano e non basta leggerlo una volta per capire l’islam. Maometto ricevette le “rivelazioni” nel corso di tre anni ma non scrisse mai nulla. I suoi seguaci imparavano a memoria i versetti pronunciati da Maometto e li scrivevano poi sui più svariati supporti. Fu Uthman, terzo Califfo, dopo la morte di Maometto, a raccogliere tutti i testi in un corpo unico di cui fece fare 4 copie e fece distruggere tutti i testi parziali precedenti.
Data la struttura della scrittura araba (senza consonanti) esistono ben 14 letture diverse del testo, prodotte dal 650 all’850 d.C. Inoltre il testo non ha una sua organizzazione logica o cronologica: le sure sono disposte per ordine di lunghezza, dalla più lunga alla più breve. Si sa soltanto quali sono state rivelate prima dell’esilio (meccane) e quali dopo (medinesi).
Cosa possiamo concludere? Come si possono conciliare versetti così contrastanti? Da come stanno le cose non sembra che i musulmani ci siano finora riusciti: o si sceglie la pace o si sceglie la guerra.
Ma come è fattibile una cosa di questo genere se il Corano originale è in Paradiso, non si può toccare e la sua interpretazione è stata congelata nel 14° secolo?
Ma anche la Bibbia…
Una obiezione che si sente fare spesso da parte dei musulmani è: ma anche voi, Ebrei e Cristiani, avete nella Bibbia istruzioni a uccidere, a sterminare i nemici ecc.! In parte dobbiamo ammettere che è vero anche se ci sono differenze non trascurabili.
La prima è certamente il fatto che gli Israeliti nella fase della conquista di Canaan combattevano per un territorio: p.es. Deuteronomio 2:31-32 e 34 Mosè racconta come gli fosse stato rifiutato dal re locale il passaggio nel paese degli Amorrei: “E l’Eterno mi disse: Vedi, ho principiato a dare in tuo potere Sihon e il suo paese; comincia la conquista, impadronendoti del suo paese. Allora Sihon uscì contro a noi con tutta la sua gente per darci battaglia a Jahats. … E in quel tempo prendemmo tutte le sue città e votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini; non vi lasciammo anima viva.”
Ma, finito quel periodo, gli Ebrei non avevano particolari mire espansionistiche e, soprattutto, non miravano a convertire gli altri popoli al Dio d’Abramo. Le loro battaglie non erano contro gli infedeli in quanto tali. Non erano guerre di religione. E noi possiamo leggere oggi quegli ordini come parte di fatti storici che rientrano nella cultura dell’epoca e siamo ben lontani dal pensare che dovremmo fare così anche noi nel nostro tempo. Nella Bibbia i passaggi violenti sono descrittivi, mentre nel Corano sono prescrittivi.
Però… purtroppo, non è sempre così…
Deut. 13.6-8 “Se il tuo fratello,… o il tuo figliuolo… ti inciterà in segreto, dicendo: andiamo, serviamo ad altri dei … tu non acconsentire, tu non gli dar retta; l’occhio tuo non abbia pietà per lui; non lo risparmiare, non lo ricettare; anzi uccidilo senz’altro; la tua mano sia la prima a levarsi su lui, per metterlo a morte…”
E questo ricorda uno dei versetti del Corano che abbiamo visto…
Num 15.30 “Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero, e oltraggia l’Eterno; quella persona sarà sterminata di fra il suo popolo. Siccome ha sprezzato la parola dell’Eterno e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere sterminata; porterà il peso della sua iniquità.”
Non ricorda da vicino la legge contro la blasfemia, applicata nei paesi islamici? E non possiamo dimenticare che Gesù fu condannato a morte dal sinedrio, proprio con l’accusa di bestemmia per essersi dichiarato il Cristo, il figliuol di Dio! Oppure possiamo citare un Salmo splendido come il 139 che trova inseriti questi versetti (21,22): “O Eterno, non odio io quelli che t’odiano? E non aborro io quelli che si levano contro di te? Io li odio di un odio perfetto; li tengo per miei nemici.” O, ancora, il Sl 137.8-9 “O figliuola di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto! Beato chi piglierà i tuoi piccoli bambini e li sbatterà contro la roccia!”
Terribile. Anche se non sono ordini a fare cose del genere, comunque sembra indubbio che esse vengono approvate, e ci lasciano con la pelle d’oca.
Nel leggere questi testi, anche se ci sentiamo un po’ a disagio, dobbiamo anche dire che non ci sentiamo realmente coinvolti da essi.
Perché? Perché non pensiamo che riguardano anche noi, che sono regole che anche noi dobbiamo seguire? Perché non ci toccano?
Perché non ci toccano?
Non so come gli ebrei, dalla diaspora in poi, abbiano elaborato questi testi ed abbiano resi innocui o non applicabili gli ordini della Legge che prescrivevano la condanna a morte, o altre punizioni violente.
Ma, per i cristiani, per me come cristiano, trovo una sola spiegazione: perché fra allora e oggi, fra loro e noi, è passato Gesù.
È lui che ha detto più volte: “Voi avete udito che fu detto agli antichi… Ma io vi dico…” E in particolare possiamo ricordare in Mt 5.43 “Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli; poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.”
È lui:
- che ha lasciato mangiare con le mani non lavate,
- che ha detto che si può mangiare di tutto,
- che ha affermato che il Sabato è per l’uomo e non l’uomo per il Sabato,
- che ha completato e riassunto la legge ed i profeti nei due comandamenti “Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua e con tutta la mente tua” e “Ama il tuo prossimo come te stesso”
- che ha reso il suo messaggio universale dicendo alla Samaritana “l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in ispirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito; e quelli che l’adorano bisogna che l’adorino in spirito e verità.”
Quindi non sul monte dei Samaritani, non nel tempio di Gerusalemme e nemmeno alla Mecca è necessario adorare il Signore.
Ecco, secondo me, il problema della riforma dell’islam sta proprio qui: avrebbero bisogno di un nuovo profeta, di uno come Gesù che possa correggere e completare il messaggio di Maometto. Ma Maometto è nato 600 anni dopo Gesù e, mentre ha pescato abbondantemente dall’Antico Testamento, non ha preso niente dal Nuovo.
Ora mi sembra difficile che appaia un nuovo profeta… quindi come uomo, cittadino di questo mondo, spero sinceramente, per il bene di tutti, che questa riforma, questa rivoluzione, questa liberazione da una ideologia soffocante e sacralizzata, come la definì il Presidente egiziano al Sisi in una prolusione all’Università Al–Azar a Il Cairo, il 28 dicembre 2014, possa realizzarsi, e presto.
Tutto a posto per noi?
Potremmo chiudere il discorso a questo punto. Tutti contenti perché la risposta ai problemi che abbiamo considerato sta in Cristo, nell’essere suoi seguaci. Ma saremmo dei disonesti se non ci chiedessimo se nel corso di duemila anni i cristiani abbiano dimostrato di essere indenni dal pericolo dell’odio in nome di Dio. E la risposta, purtroppo, sappiamo che è: NO, non ne siamo stati indenni.
Non è il caso di rifare la storia delle persecuzioni esercitate da cristiani nei confronti di altri esseri umani, cristiani o meno che fossero. Sembra banale e ovvio ricordare le stragi dei Catari, dei Dolciniani, piuttosto che degli Ugonotti o dei Valdesi, qui a casa nostra, che hanno riacquistato i diritti civili soltanto con lo Statuto Albertino del 1848. Quando si dice Inquisizione si dice tutto. Gli esempi che ho citato riguardano il mondo cattolico, ma anche i protestanti non si sono fatti mancare questi piaceri. Uno per tutti, possiamo citare il caso Michele Serveto, arrestato a Ginevra e poi condannato al rogo il 27 Ottobre 1553. Sebastien Castellion scrisse all’epoca: “Uccidere un uomo per difendere un’idea significa solo uccidere un uomo”.
Questa è la storia…
Conclusione
Alcuni nuovi atei hanno scritto libri per affermare che sono le religioni, che è l’idea stessa di Dio ad alimentare questo tipo di violenza. Dovrebbero allora dirci da quale Dio sono stati ispirati i lager nazisti, o i gulag sovietici, piuttosto che gli omicidi di Pol-Pot o, più modestamente, gli attentati delle nostrane Brigate Rosse o Nere.
No. Il problema è più profondo e universale, è dentro di noi, dentro ogni uomo. Potete anche chiamarlo peccato e si è manifestato già in Caino.
La tentazione di far valere le proprie idee con la forza è quasi irresistibile per l’uomo. Ed è indescrivibile l’euforia che può provare l’uomo quando è convinto di difendere Dio con le proprie azioni (come se Dio ne avesse bisogno…).
Ed era ovviamente così già ai tempi di Gesù.
In Luca 9:51 leggiamo: “Poi, come si avvicinava il tempo della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente in via per andar a Gerusalemme. E mandò davanti a sé dei messi, i quali, partitisi, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto a Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi? Ma egli, rivoltosi, li sgridò.”
E in Marco 9:40 “Giovanni gli disse: Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita; e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava. Ma Gesù disse: Non glielo vietate, poiché non v’è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome, e che subito dopo possa dir male di me. Poiché chi non è contro a noi, è per noi.”
E in Matteo 26.50 Gesù è nel Getsemane e sta per essere preso: “Allora accostatisi, gli misero le mani addosso, e lo presero. Ed ecco, uno di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò; e percosso il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l’orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la spada al suo posto, perché tutti quelli che prendon la spada, periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest’istante più di dodici legioni di angeli?”
Ecco i tre classici casi: distruzione di chi non vuole il nostro Dio, rifiuto di chi non sta col nostro gruppo, uso della forza per difendere Dio, che, invece, non ha proprio bisogno di noi.
Ma la lezione di Gesù è inequivocabile. Quindi?
La nostra responsabilità è tornare sistematicamente a confrontare i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti, i nostri pensieri con l’insegnamento che Gesù ci ha dato. La storia ce lo insegna e ce lo chiede.
E speriamo, preghiamo, che anche i musulmani, che cercano consapevolmente o inconsapevolmente un riformatore, lo possano trovare in Cristo, indagando nel Vangelo di cui Maometto ha pur parlato così bene. Questo potrebbe essere l’atteggiamento da tenere nei loro confronti: invitarli a leggere le parole di Gesù, che Maometto, pur non citandole, non rifiuta.

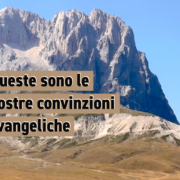



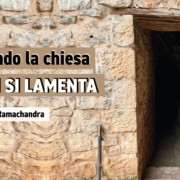



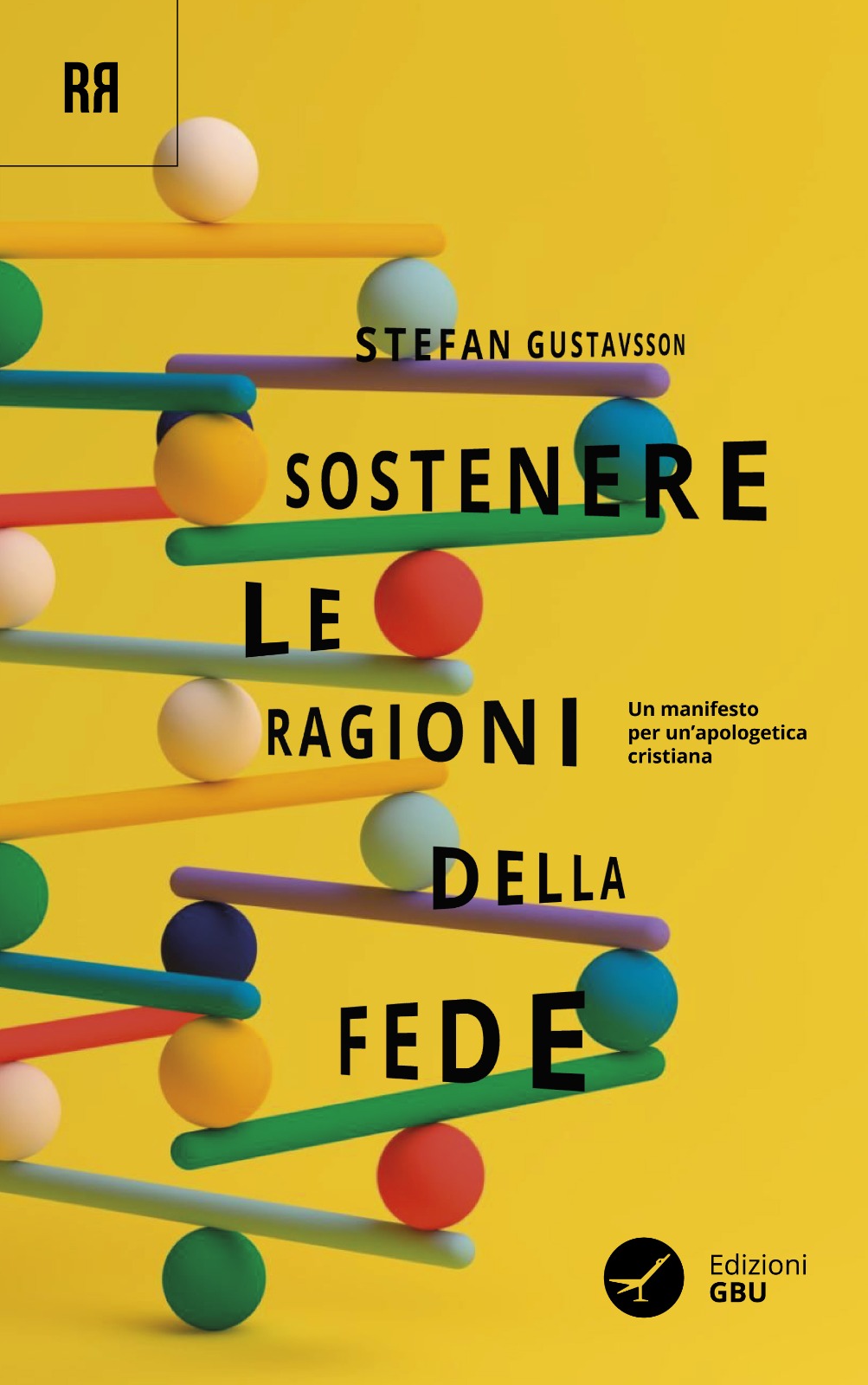 Oggi sono i fondamenti della fede a essere sotto attacco, non il modo in cui formuliamo la nostra visione del battesimo o cosa pensiamo del millennio. Dio esiste davvero o è tutta immaginazione e suggestione, una forma di autoinganno religioso? Se Dio esiste, come possiamo sapere chi egli è? Come possiamo metterci in contatto con lui? Possono avvenire miracoli in un mondo in cui possiamo descrivere tutto utilizzando le leggi della natura? I testi biblici sono attendibili? Sono parole venute da Dio? Gesù è esistito e, se è esisto, chi era? Cosa è successo dopo la sua morte e sepoltura? È vivo oggi – e dove si trova? Perché una persona non si può relazionare direttamente con Dio senza la “mediazione” di Gesù? Come possono le nostre mancanze, i nostri errori e i passi falsi – il nostro “peccato” – essere qualcosa di così grave da separarci da Dio? E come può la morte di Gesù sulla croce cambiare la situazione? È ragionevole considerare le altre religioni come vicoli ciechi? L’uomo è influenzato dall’ereditarietà e dall’ambiente, dalla biologia e dalla sociologia, è davvero libero e responsabile? E non è umiliante sottomettersi a Dio rinunciando al proprio diritto all’autodeterminazione? In poche parole, si tratta dello scontro frontale tra la fede cristiana e la visione laica della vita, indipendentemente dal fatto che essa arrivi a noi sotto forma di culto della ragione dell’umanesimo illuminista o del relativismo postmoderno.
Oggi sono i fondamenti della fede a essere sotto attacco, non il modo in cui formuliamo la nostra visione del battesimo o cosa pensiamo del millennio. Dio esiste davvero o è tutta immaginazione e suggestione, una forma di autoinganno religioso? Se Dio esiste, come possiamo sapere chi egli è? Come possiamo metterci in contatto con lui? Possono avvenire miracoli in un mondo in cui possiamo descrivere tutto utilizzando le leggi della natura? I testi biblici sono attendibili? Sono parole venute da Dio? Gesù è esistito e, se è esisto, chi era? Cosa è successo dopo la sua morte e sepoltura? È vivo oggi – e dove si trova? Perché una persona non si può relazionare direttamente con Dio senza la “mediazione” di Gesù? Come possono le nostre mancanze, i nostri errori e i passi falsi – il nostro “peccato” – essere qualcosa di così grave da separarci da Dio? E come può la morte di Gesù sulla croce cambiare la situazione? È ragionevole considerare le altre religioni come vicoli ciechi? L’uomo è influenzato dall’ereditarietà e dall’ambiente, dalla biologia e dalla sociologia, è davvero libero e responsabile? E non è umiliante sottomettersi a Dio rinunciando al proprio diritto all’autodeterminazione? In poche parole, si tratta dello scontro frontale tra la fede cristiana e la visione laica della vita, indipendentemente dal fatto che essa arrivi a noi sotto forma di culto della ragione dell’umanesimo illuminista o del relativismo postmoderno. Stefan Gustavsson,
Stefan Gustavsson, 


 Forse un aiuto in un simile rovesciamento di prospettiva può venirci dall’illuminante fatica di Paolo Ricca che nel suo Dio. Apologia (Claudiana 2022) ci fornisce un esempio, soprattutto nella prima parte, Dio nella modernità (pp. 31–151), in cui entra all’interno di molti percorsi ateisti della modernità tracciando bilanci e trovando inaspettate possibilità apologetiche.
Forse un aiuto in un simile rovesciamento di prospettiva può venirci dall’illuminante fatica di Paolo Ricca che nel suo Dio. Apologia (Claudiana 2022) ci fornisce un esempio, soprattutto nella prima parte, Dio nella modernità (pp. 31–151), in cui entra all’interno di molti percorsi ateisti della modernità tracciando bilanci e trovando inaspettate possibilità apologetiche.
 Leggevo il testo e in silenzio annuivo in quanto ero d’accordo con quanto scritto. Quando sono arrivato all’ultima pagina ho visto un disegno di una piccola mano. Pochi giorni prima stavo “leggendo” la rivista con mio figlio Nathanael, che allora aveva venti mesi. Annoiato perché non c’erano immagini di persone o animali, aveva deciso di aiutare i redattori e aveva aggiunto qualcosa di interessante nella rivista. «Papà, ruka [che in croato significa “mano”]», aveva detto mentre collocava la sua mano sulla porzione di pagine alla fine dell’articolo. Avevo preso allora una matita e avevo disegnato il contorno delle sue piccole dita.
Leggevo il testo e in silenzio annuivo in quanto ero d’accordo con quanto scritto. Quando sono arrivato all’ultima pagina ho visto un disegno di una piccola mano. Pochi giorni prima stavo “leggendo” la rivista con mio figlio Nathanael, che allora aveva venti mesi. Annoiato perché non c’erano immagini di persone o animali, aveva deciso di aiutare i redattori e aveva aggiunto qualcosa di interessante nella rivista. «Papà, ruka [che in croato significa “mano”]», aveva detto mentre collocava la sua mano sulla porzione di pagine alla fine dell’articolo. Avevo preso allora una matita e avevo disegnato il contorno delle sue piccole dita.